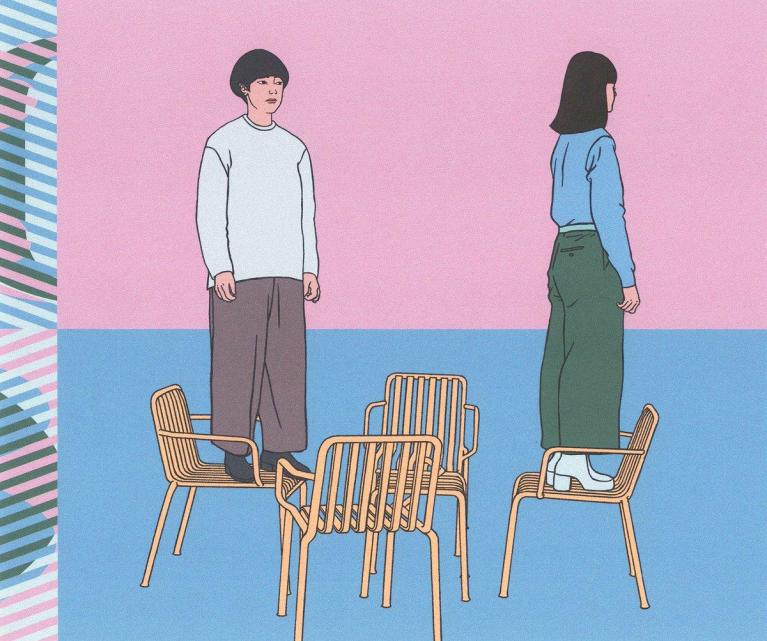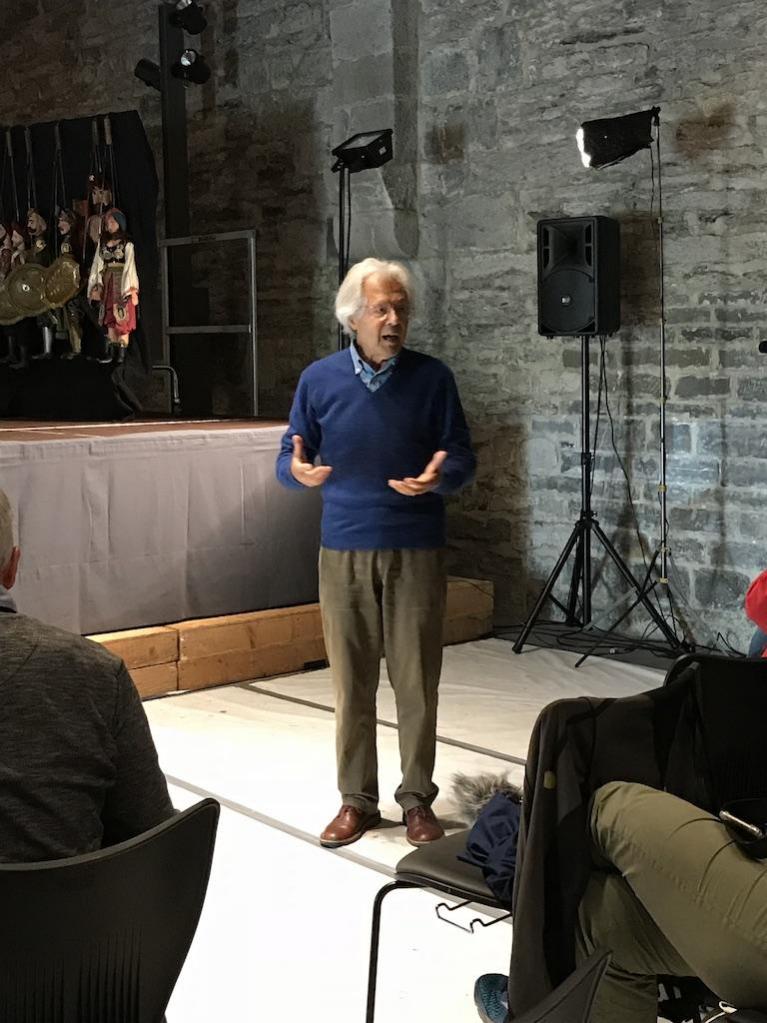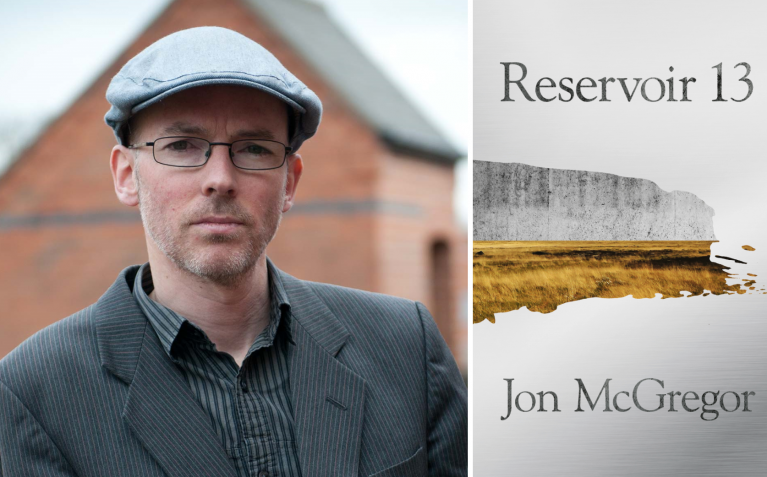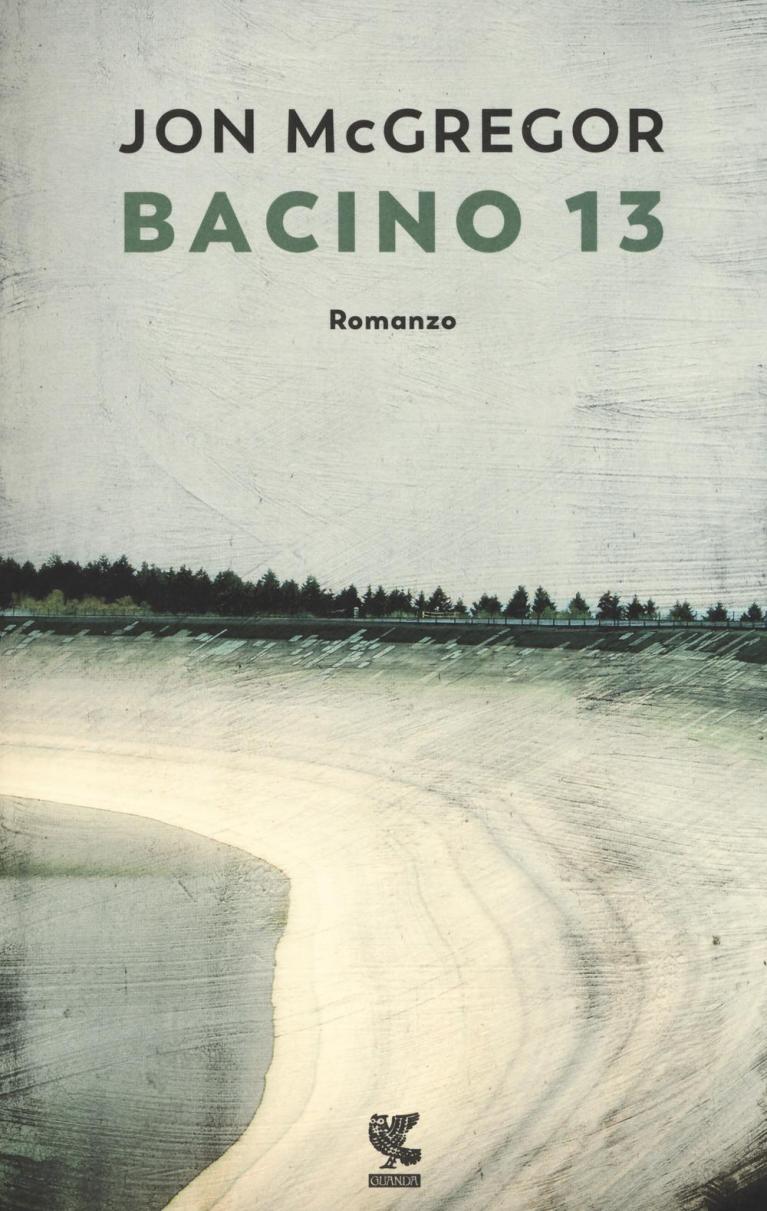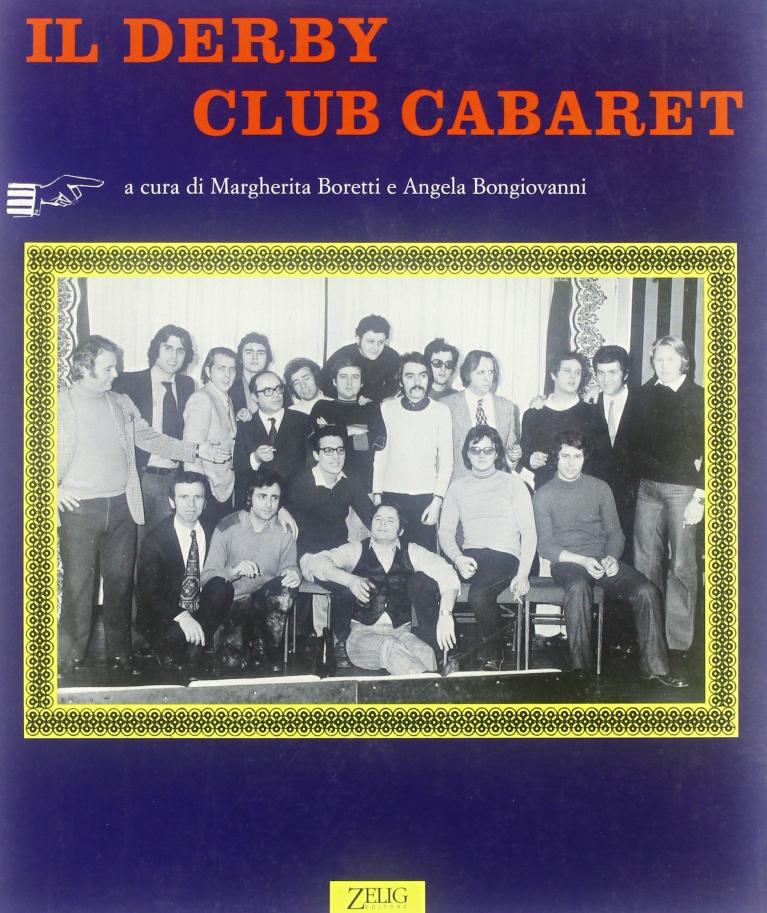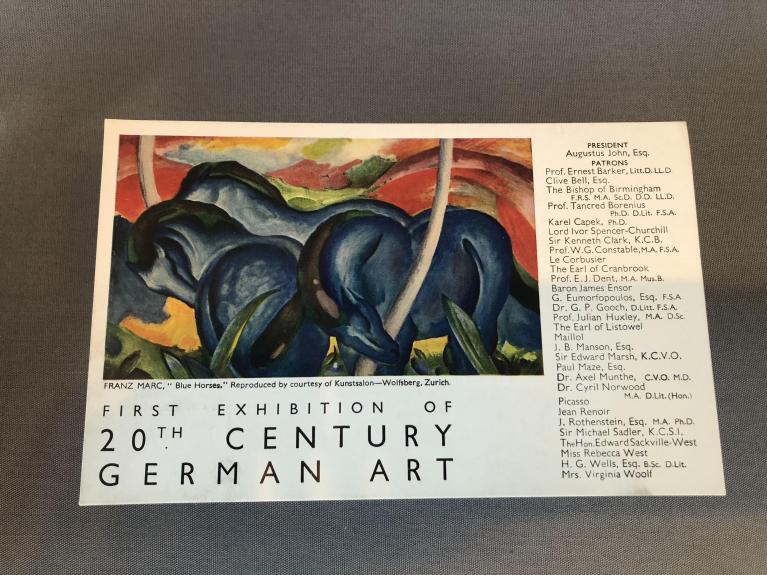La mano del bambino stringe in pugno una cordicella tesa e lunga, alla cui estremità è legato un aquilone che volteggia nell’aria tersa di un pomeriggio di aprile. Sospinto dalle folate del venticello primaverile il drago di carta si dimena, affidando la sua portanza alle sperimentate piegature che consentono alla sagoma di carta di combinare la massima leggerezza con la massima resistenza. Proprio quando sembra precipiti, ecco che all’improvviso s’impenna e ricomincia a tirare la mano del bimbo che, riprendendo a inseguirlo, molla all’occorrenza la presa del filo evitandone lo schianto a terra. Il filo attraversa lo sfondo di cielo azzurro su cui fluttuano vaporose nubi, tagliando in diagonale i filamenti di cirri che trafiggono i cumuli sospesi sopra l’acuta asprezza della vetta di una montagna, la cui maestosa e immobile possanza trova motivo di esaltazione nel confronto con la sua tremula immagine riflessa dallo specchio d’acqua antistante, in cui un fluido e sfilacciato contorno ne azzarda la triangolarità della sua forma.
Per quanto il bimbo corresse veloce su quel prato, e nonostante il rischio molto alto di vedersi affondare la scarpa in qualche zolla di terra ancora madida di rugiada consigliasse di porre più attenzione a dove poggiare i piedi, questi, uno dopo l’altro, ritrovavano puntualmente ciascuno la propria ombra che, scivolando su quanto gli si parava davanti, continuava a tallonarli in perfetto sincronismo.
La macchia verde della maglietta come per magia scompariva del tutto ogni qual volta si trovava a passare davanti alle chiome di fitte schiere d’alberi fronzuti, la cui compattezza lasciava intravedere appena i rami che le sostenevano, lasciando alla fitomorfica immaginazione dei sorveglianti dedurre se la diramazione delle nervature di ciascuna foglia replicasse la geometria dell’intera ramificazione della chioma. Nonostante l’apparente complessità di eventi e di cose che la descrizione appena letta potrebbe far pensare, la scena nella sua interezza potrebbe essere quella raffigurata dal disegno di un bambino, o di un disegnatore adulto, che abbiano voluto raffigurare in un modo alquanto canonico il ritorno della primavera. Di per sé la scena non sembra presentare nulla di particolarmente curioso o di significativo e quindi non rapisce più di tanto il nostro sguardo. Per quali motivi, dunque, un’immagine stereotipo suscita comunque il nostro interesse al punto da meritare la nostra prolusione?
La banalità e la semplicità della scena non devono sviare la nostra attenzione dalla complessità cognitiva, percettiva e grafica dei problemi che la sua riproduzione grafica tramite disegno lineare di solo contorno, comunque cela.
Se consideriamo con maggiore attenzione il nostro disegno, ci accorgiamo che esso contiene un campionario di discontinuità fenomeniche che, nonostante segnalino ineludibili differenze di proprietà ottiche, materiche, di forma, di colore, di superficie, di densità, di dimensione, di resistenza, di compattezza, … sono disegnate tutte con un unico tratto di matita o di penna, un tipo di linea uniforme e monotona, sempre uguale a se stessa, che corre come un filo nero lungo i bordi delle cose, circoscrivendone il contorno, insensibile al fatto che ognuna di essa possieda una propria natura fisica.
In natura non ci sono linee, né tanto meno, corrono fili neri ai margini delle cose. Tuttavia, la percezione visiva individua nel confine spaziale il motivo essenziale della forma. La discriminazione della forma delle cose deriva principalmente dalla variazione, o dalla discontinuità, della luminosità nei punti che delimitano la figura della proiezione ottica di un dato oggetto. Ma essendo il limite della cosa unico e inseparabile da essa e le sfumature dei margini tanto indefinite quanto infinite (quindi entrambi irrappresentabili), siamo costretti a tentare di afferrare questo limite conferendogli un ineffabile profilo unilaterale. Si impone una linea, dunque, pur non possedendo un’esistenza fattuale, ma unicamente effettuale.
La linea, correndo sulla superficie ne incrina sì l’isotropia, ma ne inaugura una nuova profondità che la vivifica e la rende ancora più luminosa di quanto fosse prima: la trasforma da superficie opaca a sfondo di diafana bianchezza. Quando si traccia una linea su di un foglio, ciò che viene inciso non è il supporto materico della carta, quanto il bianco dello sfondo, che notoriamente oppone più una resistenza psichica che fisica.
Il contorno è l’elemento minimo della visibilità che rende visibile pur essendo in sé stesso invisibile, una traccia di inchiostro opaco che non esiste ma che ci fa vedere la forma rappresentata delle cose reali e immaginarie, e che, nel farlo, svanisce dalla nostra visione lasciando il posto alla forma che delimita.
Occorre spiegare perché cose molto diverse possano essere disegnate tutte con la medesima linea e anche perché lo stesso tipo di linea possa condensare una così ampia densità informativa, riguardante “livelli di realtà” del tutto distinti, che chiamano in causa differenti attività cognitive, percettive, immaginative e logiche. Non è la linea nera ad appartenere alle cose, ma la forma dello spazio da essa racchiuso, a configurarsi con un aspetto riconoscibile.
La linea di contorno è un segno che rimanda a un vasto orizzonte referenziale. La constatazione che i differenti ordini di oggetti presenti nella nostra semplice scena siano tutti riproducibili con un’unica linea, mentre nella nostra esperienza percettiva chiamano in causa diverse modalità sensoriali, dimostra quanto sia astratto e convenzionale il segno lineare che ne riproduce visivamente la forma. Al fine di rendere ancora più chiaro questo punto proviamo a distinguere in categorie logiche e percettive le linee che delimitano la forma degli oggetti riprodotti nella scena primaverile descritta sopra e che afferiscono a diversi ordini di realtà fisica e fenomenologica. Prospettiamo, quindi, sia pure in modo incompleto, una prima schematica sintassi delle linee, quale abbrivio di una più completa formalizzazione delle discontinuità grafico-visive.
A - Lacordicella, i fili d’erba, i rami, le nervature delle foglie, le pieghe dell’aquilone, l’impronta impressa dalla scarpa nella zolla, costituiscono solo alcuni esemplari di discontinuità tattilo-visive tra le quali si possono includere: tutti i tipi di discontinuità sulle superfici determinati dalla alternanza di minimi rilievi e/o concavità (scanalature, rigature, nervature, crepe, incisioni, incastri, contiguità), le estremità delle forme piane (foglie, lame, vetri, lamiere), le discontinuità della curvatura di superfici piane e tridimensionali (bordi di un bicchiere, di una lampadina, ecc.), le discontinuità di inclinazione o di direzione delle superfici piane e tridimensionali che formano angoli diedri (tutti i tipi di spigoli concavi e convessi). Sul piano della rappresentazione grafica queste linee costituiscono una specifica categoria, quella delle linee-oggetto, ovvero delle linee che si vedono e si toccano.
B - La forma della montagna unitamente alla sua immagine riflessa nell’acqua, la forma delle nuvole, dell’ombra proiettata dal corpo del bimbo, della chioma degli alberi, costituiscono invece una serie di discontinuità ottiche; un repertorio molto vasto di discontinuità comprendenti oltre alle discontinuità di forma delle grandi masse volumetriche viste in lontananza (profili di montagne, linee di orizzonti), anche tutti i fenomeni dovuti alle discontinuità di illuminazione, di riflettenza, di pigmentazione (livrea degli animali, colori dei tessuti). La traduzione grafica di queste discontinuità costituisce la categoria delle linee che si vedono ma non si toccano. Esse, cioè, presentano una realtà fisica esclusivamente ottica e sono pertanto esperibili soltanto con la visione.
C - La direzione delle folate del venticello, le correnti d’aria, la forza di gravità, la traiettoria del volo dell’aquilone, l’irradiamento delle forze di crescita nelle piante e nelle foglie, la direzione dei raggi di luce, sono tutti esempi riconducibili alle discontinuità virtuali o potenziali, tra le quali si possono aggiungere anche le traiettorie, le rotte, le linee delle correnti marine, tutti i vettori di direzioni, le linee dello sguardo, le linee di sviluppo, le direzioni di tutti i tipi di movimenti la cui velocità si pone al di sotto o al di sopra delle soglie assolute della percezione visiva (troppo lenti o troppo veloci per essere percepiti). Siamo cioè in presenza di una categoria di linee che non si vedono e non si toccano, ma che esistono e si “avvertono” in virtù di qualche deduzione intermodale.

D - Il completamento della forma dei rami che affiorano parzialmente tra le fronde, il completamento del corpo del bimbo, quando la maglietta verde si confonde con le chiome degli alberi, costituiscono una casistica molto particolare, comprendente anche le occlusioni parziali, le contiguità “visive” tra forme poste in luoghi e distanze differenti nello spazio. Sono definibili come discontinuità amodali, relative a tutti quei fenomeni in cui il contorno apparente delle forme è incompleto, perché occluso, oppure perché alcune parti non inviano alcuno stimolo ottico-fisico. Nonostante questa amodalità fenomenica l’occhio riesce comunque a percepire la forma nella sua interezza, aggiungendoci le parti mancanti, in virtù dei principi gestaltici della bontà e della chiusura, ma anche ricorrendo all’esperienza del soggetto percipiente.
E - Relativamente alle dinamiche e agli eventi raffigurati nella scena si potrebbe dedurre una vasta quantità di dati, con un diverso grado di attendibilità, inerenti alle misurazioni della pressione atmosferica, della velocità del vento, della posizione del sole e della relativa distanza della terra, della velocità di corsa del bambino, della temperatura atmosferica e di quella corporea del bambino, al calcolo delle probabilità che l’aquilone percorra una data distanza e rimanga in volo in un dato lasso di tempo, ecc. Tutti questi dati possono essere tradotti in grafici, diagrammi, istogrammi; possono, cioè, essere rappresentati mediante delle linee la cui funzione è quella di visualizzare delle discontinuità logiche.
F - L’eventuale inferenza sull’albero genealogico del bambino, sull’influsso delle costellazioniastrologiche alla sua nascita, darebbero luogo a delle rappresentazioni grafiche che si possono genericamente catalogare sotto l’etichetta di proiezioni, o disegni dell’immaginario composti da linee che non esistono realmente ma che visualizzano delle pure proiezioni immaginarie, ovvero delle discontinuità eidetiche.
La nostra scena potrebbe essere l’immagine finale di una sequenza di altri disegni che illustrano una guida, un manuale, inserito all’interno della confezione che conteneva l’aquilone. Potrebbe trattarsi dell’ultimo di una sequenza di disegni destinata a trasmettere delle informazioni relative al montaggio dell’aquilone. Un genere, quindi, di disegno predisposto a visualizzare le istruzioni per l’uso, le informazioni relative alla lunghezza della corda, alla tensione a cui bisogna tenerla, al modo in cui la si deve legare, ecc. Un genere di disegno estremamente chiaro, essenziale nei segni, elementare nella sequenza delle fasi, di facile e immediata leggibilità, che presenta in breve i tratti e le forme di codificazione tipiche dei cartoon, dei disegni animati alla Walt Disney.
Questo tipo di disegno, per garantire l’immediato riconoscimento di quanto riproduce, deve necessariamente presentare i caratteri schematici di uno stereotipo visivo, strutturato su quegli invarianti visivi selezionati a trasmettere un significato univoco nel minor tempo possibile. L’economia visiva che struttura l’immagine canonica di un oggetto impone al disegno un’essenzialità dei tratti necessari a visualizzare l’immagine mnemonica che si forma nella mente di ognuno di noi, dopo aver osservato per un congruo numero di volte la stessa cosa. È stato provato sperimentalmente che i tempi impiegati dall’occhio per riconoscere un oggetto raffigurato con la sola linea di contorno risultano molto più brevi rispetto a qualunque altro sistema di rappresentazione grafica, pittorica e fotografica del medesimo oggetto.
Questo perché le linee di contorno estremamente esemplificate richiedono un numero di fissazioni oculari inferiore a quello richiesto dalle altre immagini. L’esperimento dimostra inoltre che, in una rappresentazione visiva, quanto più è alto il livello di economia dei suoi tratti, tanto più soddisfacente e immediato sarà anche il riconoscimento dell’oggetto riprodotto.
Supponiamo di trovare la nostra scena primaverile riprodotta da un disegno al tratto impresso su di un cartello segnaletico, destinato a indicare l’inizio dell’area di suolo pubblico preposta ai giochi dei bambini, situata all’interno di un parco cittadino. Ci troveremmo, quindi, davanti a un disegno che presenta le caratteristiche dei pittogrammi, quelle cioè dei disegni ottenuti per forte contrasto di chiarezza tra lo sfondo, quasi sempre bianco, e le figure colorate di nero a tinta piatta e uniforme. La ricerca del contorno miglioreè l’aspetto più rilevante nella codificazione dei pittogrammi segnaletici dato che la loro funzione è proprio quella di trasmettere informazioni univoche.
Tuttavia, quanto, della forma di un oggetto che muta ad ogni minima variazione del suo orientamento spaziale, sia da considerare superfluo o insignificante, privo comunque di informazioni rilevanti e necessarie al suo riconoscimento e quanto, invece, sia da ritenere assolutamente essenziale e necessario, al punto che una eventuale carenza nel contorno ne comprometterebbe il riconoscimento visivo, non è come sembra un problema di semplice soluzione. L’occhio sa che ogni punto di vista offre informazioni uniche, relative a quel particolare orientamento della forma, che appaiono visibili solamente da quel punto di vista. Sa altrettanto che nessun orientamento può mostrare tutto ciò di cui si compone un dato oggetto; né quanto di quell’oggetto caratterizza la sua morfologia. Queste condizioni spingono l’occhio a fare delle selezioni, a operare delle connessioni virtuali, dei richiami visivi, tra quanto appare visibile in un dato orientamento e quanto rimane inapparente, invisibile sotto quel medesimo orientamento. L’occhio per riconoscere la forma di un oggetto deve sapere mettere in continuità piani, spigoli, contorni, superfici apparenti con quelle inapparenti o invisibili dai singoli punti di vista. L’occhio, cioè, per poter riconoscere la forma di un oggetto deve completare sempre quanto appare visibile con quanto rimane invisibile, deve operare una continuità spaziale e morfologica tra il visto e il non visto: senza questa integrazione ogni forma risulterebbe parziale, incompleta e quindi irriconoscibile. Anche la forma della cosa più nota, se osservata con un particolare orientamento può presentarsi con uno scorcio prospettico così inconsueto da rivelare un contorno del tutto insolito, da non consentirne il riconoscimento.
Ma come si fa a vedere una forma staccata dalla cosa in cui appare, dalla qualità tattile della superficie e dalla materia?
Innanzitutto, dirà Valéry, il vedere per disegnare presuppone un superamento del modo abituale di vedere, vuol dire esercitare quell’intelligenza dell’occhio che fa del vedere una sorta di costruzione del visibile, dalla quale l’assuefazione ci dispensa, ma che rappresenta l’unica strada che ci permette di cogliere e distinguere ogni elemento come una presenza singolare. Sostanzialmente il disegno potrebbe essere ridotto a un unico elemento strutturale: la linea di contorno. Questa linea è già essenzialmente disegno; è il disegno allo stato puro. Essa condensa simbolicamente una polisemia di concetti come confine, orlo, bordo, profilo, margine, limite... la cui portata teorica travalica lo specifico e si estende in molti altri ambiti disciplinari, quali la matematica, la geometria, la biologia, la geografia e la filosofia. Nel linguaggio grafico, però, l’accezione geometrica della linea unidimensionale è soltanto una delle possibili codificazioni grafiche, giacché nel disegno artistico la linea di contorno, per sottile che sia, è sempre considerata una componente dotata di “forma”, di “colore”, di “valore luminoso” e persino “tissurale”. Il disegnatore conosce bene tutte le proprietà materiche dello strumento e le modalità tecniche adeguate a sfruttarne le potenzialità espressive. Ciascuna linea, tracciata sopra un foglio di carta, corrisponde a una precisa quantità di una particolare materia (un pigmento dotato di consistenza fisica), per cui occupa uno spazio e possiede anch’essa una forma di proprio conto.
II contorno rivela il dialogo intimo e serrato che la linea intrattiene con la forma, nella loro reciproca corrispondenza: come la linea si piega alla plasticità della forma, così quest’ultima offre il fianco a carezzevoli lineamenti. Tra l’una e l’altra esiste un indissolubile legame, una connivente interazione di infinite sfumature espressive. A tale scopo è molto facile verificare quanti slittamenti di senso avvengano assegnando contorni diversi alla stessa forma. Quanto più prende consistenza e peso espressivo l’una, tanto più si astrae e si eclissa l’altra: l’incontro ideale si ha quando “nel canto della linea si rivela la verità della forma” (Wolfflin H.).
Quando disegniamo il contorno di una cosa, ne tracciamo l’unico possibile o uno dei tanti? Le cose non hanno un solo contorno, ma infiniti contorni, tanti quanti sono i punti di vista dai quali possiamo vederle, anche se, di tutti quelli possibili, alcuni mostrano maggiori informazioni visive circa la forma globale, mentre altri ne mostrano pochissime, ed altri ancora mostrano con un profilo persino deformato o del tutto irriconoscibile.
Nell’ambito del disegno artistico la linea di contorno non può essere considerata solamente sotto l’aspetto puramente concettuale o geometrico, ma si impone necessariamente una attenta e sensibile considerazione delle sue potenzialità espressive, in rapporto alle qualità plastiche della forma che racchiude. Ogni disegnatore sa che la resa ottica della dimensione, della materia, della superficie, della forma, della distanza da cui guardiamo la cosa che si vuole disegnare, dipende dalla sensibilità con cui trattiamo graficamente i suoi lineamenti. Per un pittore non è possibile astrarre la linea dalla forma che essa delimita; tutto deve interagire e integrarsi nel rispetto di particolari esigenze espressive e di precisi scopi comunicativi. Di fatto andrebbe considerato che ogni cosa ha un suo contorno.
Quali e quante relazioni intrattiene la linea di contorno con la forma che delimita?
Si possono enucleare quattro fondamentali tipi di relazioni che il contorno intrattiene con la forma:
- 1) un solo contorno per tutte le cose: carattere cognitivo-simbolico; la linea svolge una funzione convenzionale, simbolica e cognitiva; la relazione “uno per tutte” le conferisce un carattere di universalità linguistica, di segno assoluto;
- 2) tutti i contorni di una sola cosa: carattere fenomenico-informativo; “tutti” sta per gli “infiniti” contorni che formerebbero la visibilità totale di una cosa, ciascuno dei quali è direttamente riferibile a un determinato punto di vista, che a causa della propria “unilateralità” può fornire soltanto parziali livelli informativi;
- 3) differenti contorni per una sola cosa: carattere estetico-comunicativo; la “varietà” degli aspetti di forma, colore, materia, numero... che concorrono nel tracciamento del contorno entrano in relazione con la forma della cosa disegnata, aggiungendovi inesauribili possibilità di connotazioni estetiche;
- 4) ogni cosa con il suo contorno: carattere empatico-espressivo; lo stato di singolarità (ogni) della cosa implica il riconoscimento della sua identità, che rivendica il diritto ad avere una corrispondenza “empatica” con il “timbro” lineare del contorno che la delimita.
L’esercizio del disegno esplica una forza formante basata sulla capacità di concentrazione dello sguardo, che lavorando tra il conoscere e il costruire, tra il rilevare e il formare, è costretto a discriminare quel che per troppa evidenza è diventato invisibile. Per questa sua peculiare modalità, il disegno si manifesta come una delle più alte forme di intelligenza, in quanto consente di rendere il massimo delle nostre intenzioni e delle nostre impressioni con il minimo dei mezzi a disposizione; in questo senso la sua natura si colloca a metà tra il fisico e lo spirituale.