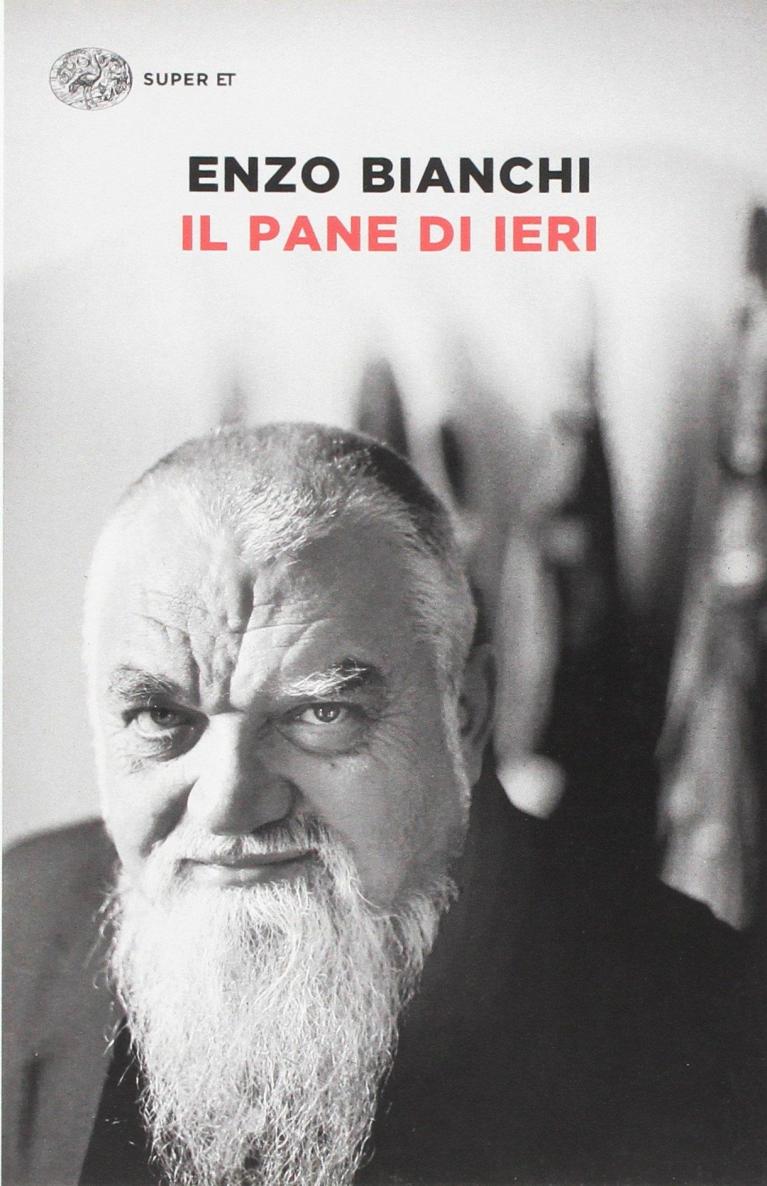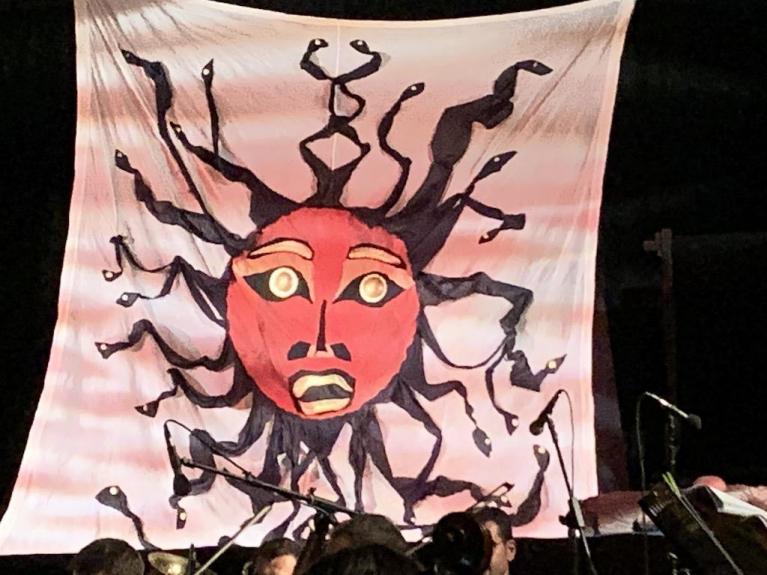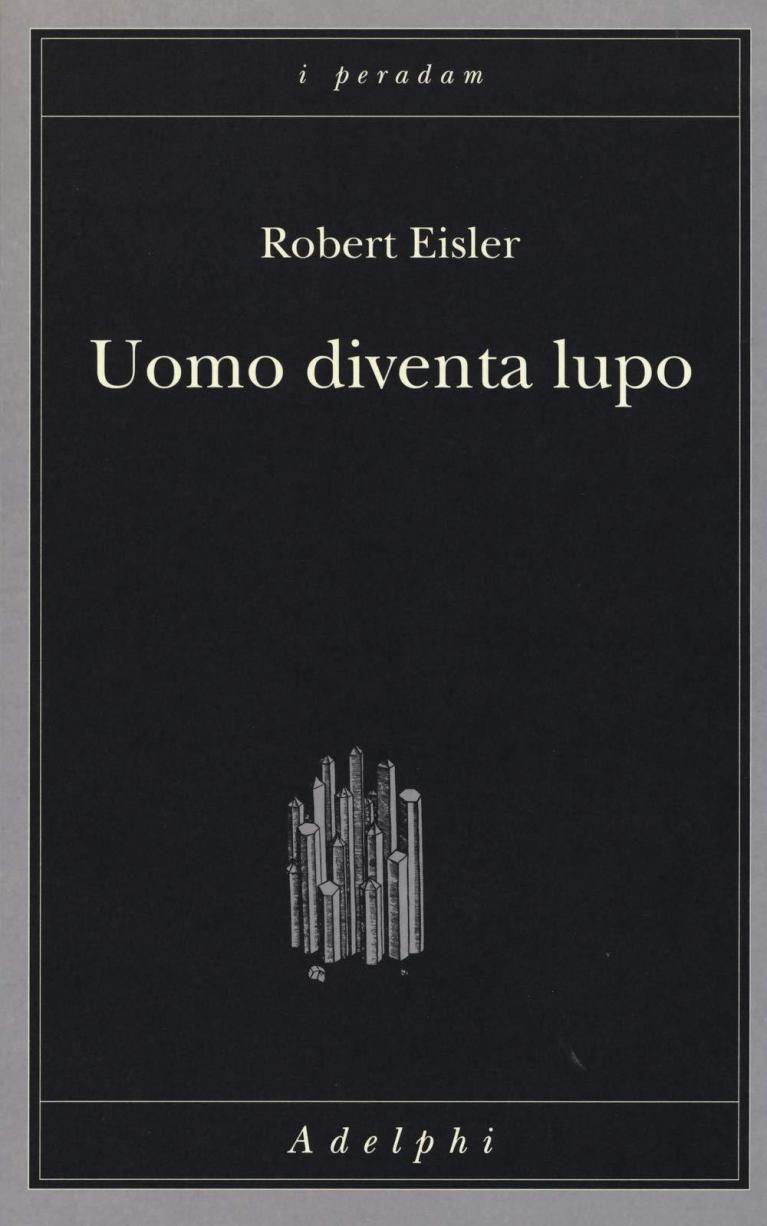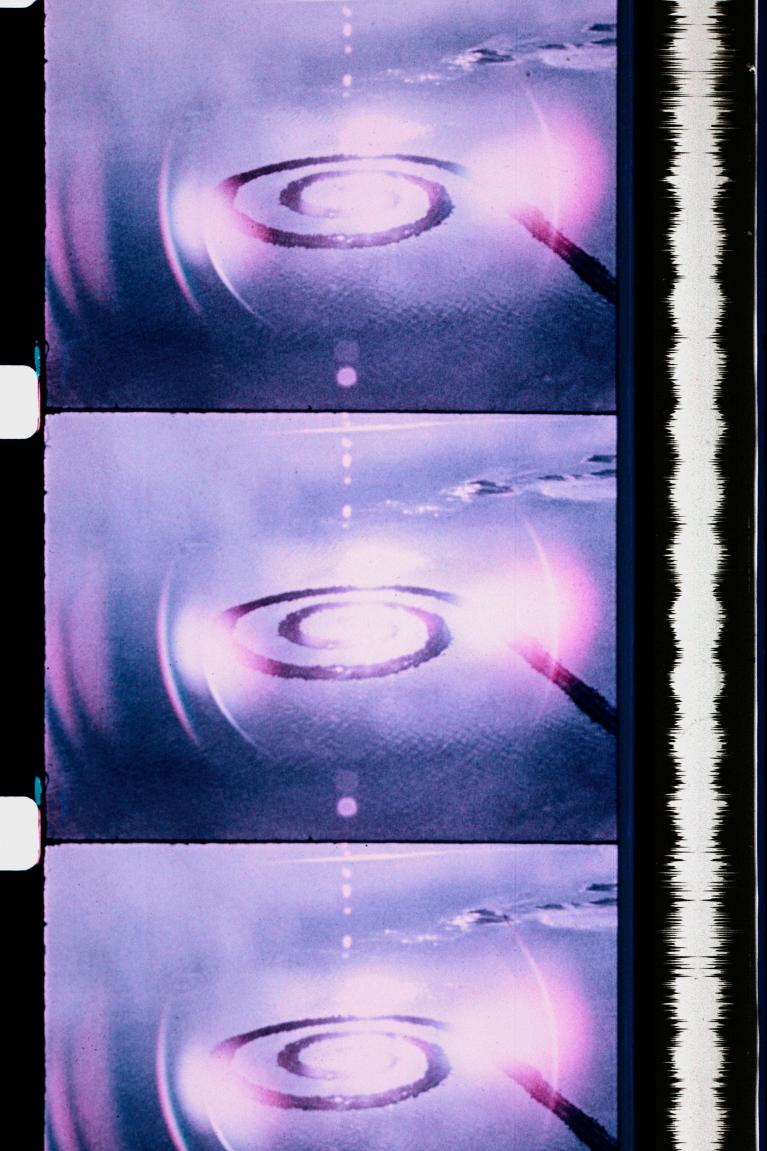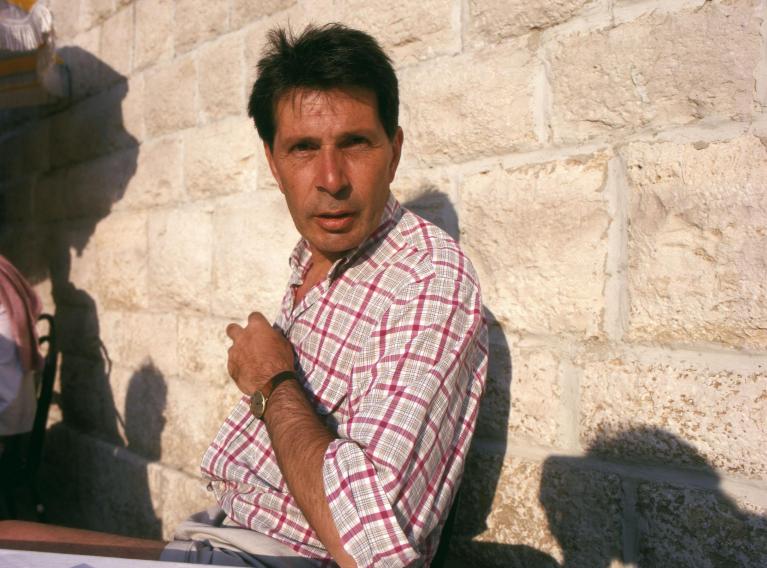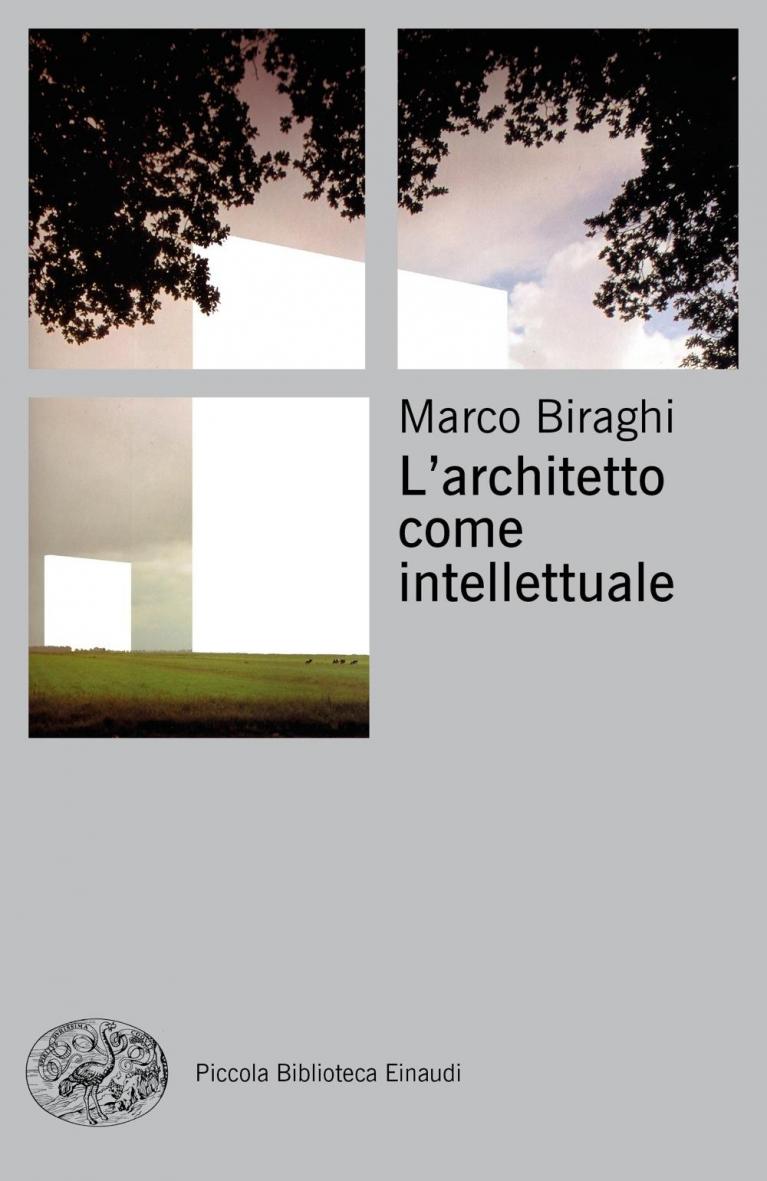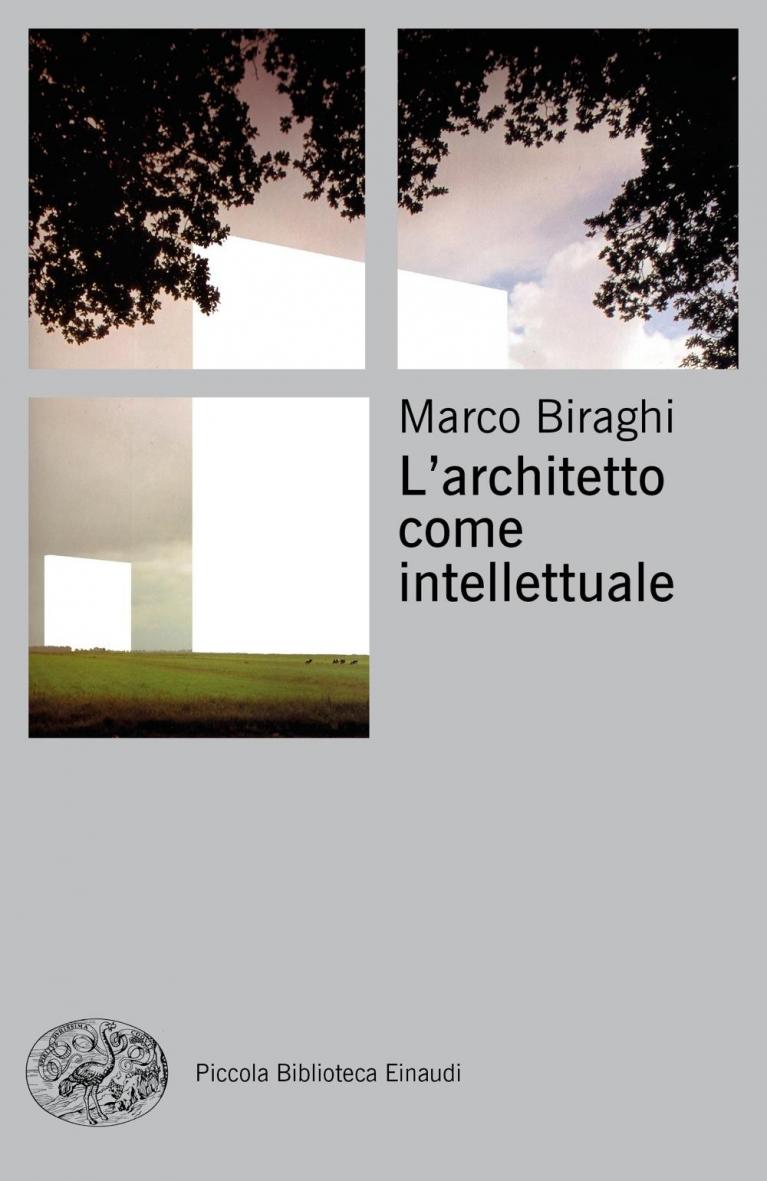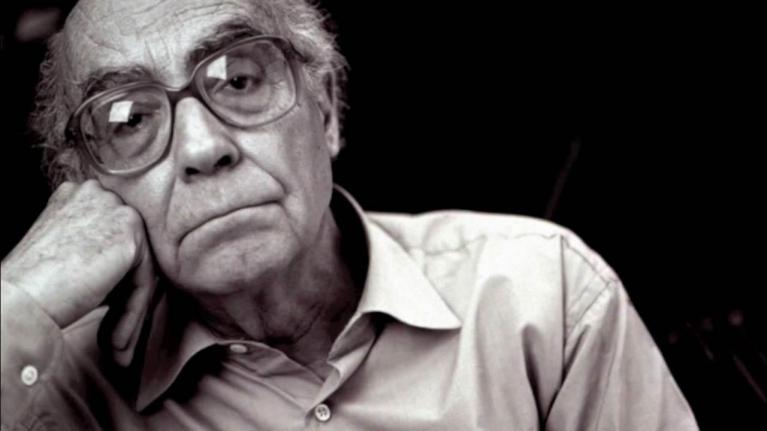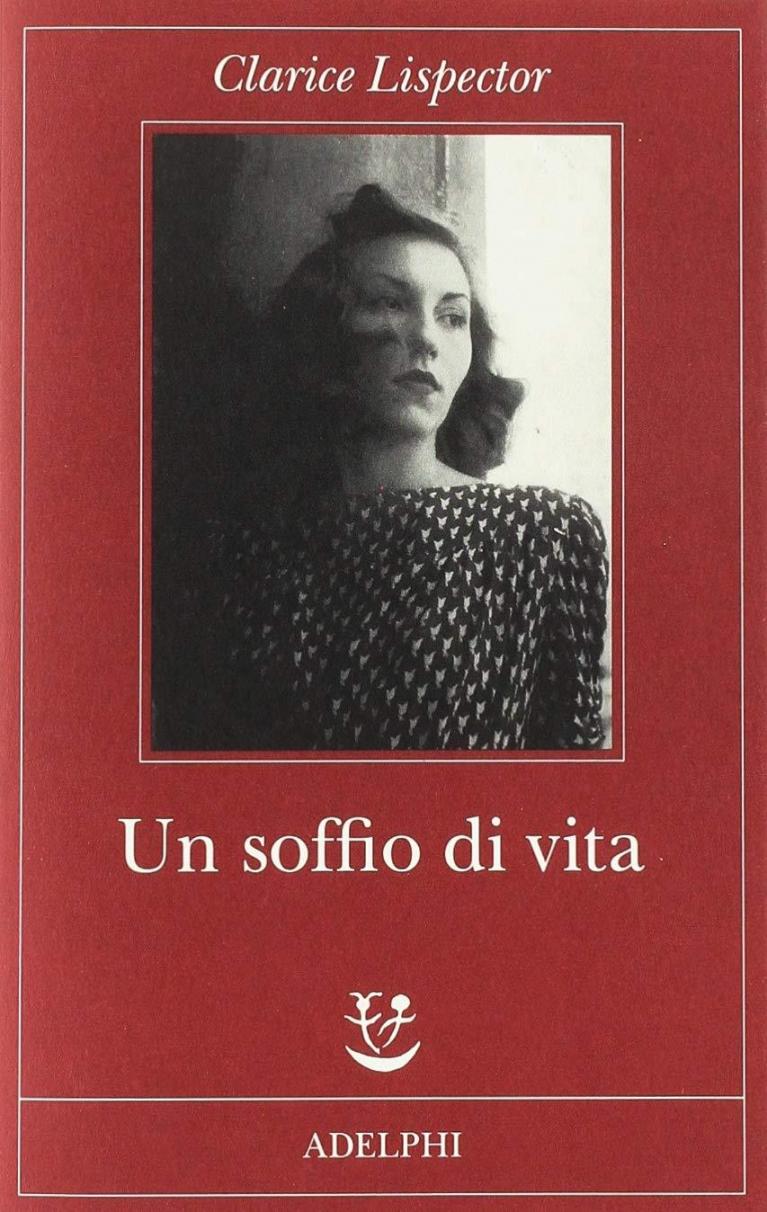Préhistoire, un énigme moderneè il titolo della mostra curata da Cécile Debray, Rémi Labrusse e Maria Stavrinaki al Centre Georges Pompidou di Parigi fino al 16 settembre. Non si tratta dell’ennesima mostra sulla preistoria ma di una traversata originale e appassionante, piena di colpi di scena, incentrata sul fascino esercitato dalla preistoria sugli artisti lungo il XX secolo. Un fascino che ha avuto conseguenze sulle loro idee artistiche e antropologiche così come sulla loro percezione del mondo e dell’umanità. Con la consapevolezza che ogni quête dell’origine rende allo stesso tempo pensabile il futuro.
Tante sono le questioni sollevate da Préhistoire, un énigme moderne attraverso la selezione parallela di opere d’arte contemporanea e di manufatti preistorici visibili, questi ultimi, nelle migliori condizioni immaginabili.
Ad aiutarci a pensare i legami, spesso sotterranei, tra preistoria e modernità ci pensa un catalogo di oltre 300 pp. che ripercorre le otto sezioni della mostra – Lo spessore del tempo; La terra senza gli uomini; La nascita dell’idea di preistoria; Uomini e bestie; Gesti e strumenti; La caverna; Neolitici; Presenti preistorici –, arricchito dai testi dei tre curatori e da approfondimenti brevi e puntuali.
Diverse le pubblicazioni uscite in occasione della mostra, tra cui ricordo: la monografia del co-curatore della mostra Rémi Labrusse, Préhistoire. L’envers du temps (Hazan 2019) che ricostruisce il modo in cui l’idea di preistoria si è costituita nella mente e nelle opere degli artisti moderni; il numero monografico della rivista “Les Cahiers du Musée national d’art moderne” (147, primavera 2019), composto da un’antologia e da una serie d’interviste con artisti contemporanei. La stessa rivista ha tra l’altro già consacrato alla preistoria un numero precedente (Préhistoire/Modernité, 126, inverno 2013-2014) su iniziativa di due dei tre curatori di Préhistoire, un énigme moderne: M. Stavrinaki e R. Labrusse.
È con Maria Stavrinaki che mi sono intrattenuto in una lunga conversazione ricca di spunti, ripercorrendo il percorso della mostra parigina, che le ha permesso di rivenire su alcuni snodi cruciali.
Professoressa in storia dell’arte contemporanea alla Sorbona nel dipartimento di Arts plastiques, Maria Stavrinaki lavora da anni sul fascino tutto moderno per la preistoria; al riguardo ha recentemente pubblicato Saisis par la préhistoire. Enquête sur l’art et le temps des modernes (Presses du réel 2019): una storia della modernità che, risalendo al XIX secolo – quando la preistoria viene inventata –, tiene conto del tempo profondo proprio all’età della Terra, all’età dell’uomo e all’età dell’arte, scardinando così ogni idea corriva di progresso.
Enigma
“Preistoria. Un enigma moderno”: vorrei cominciare la nostra discussione dal sottotitolo della mostra e dalla nozione di enigma che m’intriga molto. Ho notato che si ritrova spesso nelle pubblicazioni consacrate alla preistoria; mi viene in mente quella di Daniel Fabre, Bataille à Lascaux. Comment l’art préhistorique apparut aux enfants (L’échoppe, Parigi 2014).
Oggi è difficile associare le arti visive – l’arte contemporanea in particolare – all’enigma, a un’immagine che va decifrata, a un senso nascosto che sfugge al primo sguardo e apre a temporalità estese.
È vero che la doxa della modernità disincantata si combina male con la nozione di enigma. Tuttavia, la preistoria è uno dei tanti enigmi che la modernità ha dovuto inventarsi al fine di garantire la sua stessa inventività, la sua capacità di rappresentazione, persino la sua storicità – una storicità finalmente affrancata da un passato scritto, conosciuto, obsoleto. Un aspetto ancora più importante è il fatto che l’enigma della preistoria rimanga senza risposta, diventando in questo modo inesauribile.
Fin dalle prime invenzioni che l’hanno costituita come oggetto della coscienza occidentale, la preistoria è stata vissuta come un “enigma”, nel senso di un’invenzione sorprendente che contrastava con le verità stabilite e non riusciva a trovare uno spazio naturale o coerente nel sistema delle rappresentazioni degli anni 1830-1900, quando si sono formate l’età e la disciplina che denominiamo “preistoria”.
La preistoria è l’opposto dell’enigma della Sfinge posto a Edipo, in quanto il pensiero antropologico che ha attivato si basa su discorsi destinati a restare transitori e che corrono il rischio di diventare tutti potenzialmente obsoleti. Si ha l’impressione di guadagnare del tempo scavando nel passato, mentre in realtà deploriamo – oggi più che mai – l’assenza di futuro.
![Vista della mostra Préhistoire. Une énigme moderne, Centre Pompidou, Philippe Migeat, 2019.]()
Vista della mostra Préhistoire. Une énigme moderne, Centre Pompidou, Philippe Migeat, 2019.
L’enigma è anche, alla lettera, un “parlare oscuro” che si lega, mi sembra, all’oscurità della prima sala della mostra parigina.
Non c’è, o non c’è più, alcun enigma oggi. Forse perché, all’era digitale, le immagini sono troppo presenti o lisce perché si formi una piega sulla loro superficie. È cosi che Préhistoire. Un énigme moderne ci offre, sin dal titolo e dalla prima stanza, un universo visivo e concettuale inedito, dove la dimensione enigmatica – o, se preferisci, allegorica – gioca un ruolo centrale nella comprensione di quest’attrazione moderna per un tempo che precede l’invenzione della storia.
Hai ragione a osservare che l’ingresso alla mostra spazializza il sottotitolo: è uno spazio immerso nel buio, ma anche uno spazio vuoto, punteggiato e illuminato da due soli oggetti. Prima il cranio dell’uomo di Cro-Magnon (forma dimenticata di noi stessi ritrovata nel 1868 nel sottosuolo di Eyzies), poi il piccolo quadro di Paul Klee, intitolato Die Zeit, realizzato nel 1933. È una convergenza di scale temporali, ma anche di discipline, in particolare di antropologia e storia. Questa convergenza non viene esplicitata, non c’è alcun testo che ne spiega la logica, fatta eccezione per due versi di Borges che evocano il fondamento della soggettività su un passato infinito che sfugge. Lo spettatore è incoraggiato a formulare e tessere le proprie ipotesi, a farsi carico dell’enigma della preistoria, pur restando naturalmente “condizionato” dalla scenografia, assai teatrale, di questo spazio.
Libertà e costrizione sono i due concetti opposti qui operanti. Ma credo che questa iniziazione sensibile e assieme concettuale non sia così estranea all’arte contemporanea: l’invenzione stessa della preistoria è dovuta a un eccesso di storicismo – volendo storicizzare la totalità del conosciuto, ci siamo scontrati con l’ignoto, ed è la stessa mole di conoscenze, immagini, archivi d’ogni genere che ci rende oggi così sensibili all’enigma della preistoria. Attraverso la lunga modernità, c’impadroniamo di tutto con lo scopo segreto, a volte, di disfarcene.
Corrispondenza
Prima di addentrarci nei paradossi della temporalità che hai appena evocato – propri alla costituzione della preistoria nella seconda metà dell’Ottocento ma anche alla crescente difficoltà di immaginare il futuro di fronte alla sesta estinzione innescata dall’era dell’Antropocene – riveniamo sul percorso di Préhistoire. Un énigme moderne.
Il cranio dell’Homo sapiens da un lato, Die Zeit di Paul Klee (realizzato nel 1933: la data non è un dettaglio....) dall’altro: che il loro rapporto non sia esplicitato è ben restituito dalla stessa installazione: tra di loro c’è uno spazio, una spaziatura o addirittura una vertigine temporale incommensurabile che resta a noi spettatori riempire o, perlomeno, prendere in carico. È necessario spostarsi fisicamente dall’uno all’altro in uno spazio immerso nell’oscurità e senza punti di riferimento, unico modo di tenerli insieme e misurarne la distanza siderale dal punto di vista temporale, formale e così via.
Una delle difficoltà nella concezione della mostra è stata quella di realizzare una narrazione storica che fosse al tempo stesso articolata e aperta alle interpretazioni altrui. Bisognava prendere in considerazione la natura ripetitiva degli usi moderni della preistoria – temi, strutture e paradigmi che ricorrono con costanza, indipendentemente dalla singolarità specifica degli individui e dei contesti storici. Ma bisognava anche riconoscere pienamente la differenza storica, vale a dire le specificità dovute alla scoperta dei singoli oggetti (ad esempio Lascaux, Chauvet o la Venere di Lespugue), alle dinamiche politiche e sociali, agli approcci individuali, così come all’emergere del nuovo in modo più generale.
Eventi come la Prima Guerra Mondiale, la cui natura tecnica e impersonale ha favorito l’interesse per i fossili piuttosto che per le forme simboliche della preistoria, o come la Bomba atomica, che ha suscitato un entusiasmo senza precedenti per lo spazio della caverna e per un discorso sistematico sulla post-histoire, hanno determinato l’uso della preistoria da parte di artisti, scrittori, filosofi in determinati momenti.
![Cézanne, La Montagne Sainte-Victoire vue des carrières de Bibémus, 1898-1900, olio su tela, 65x81 cm, The Baltimore Museum of Art.]()
Cézanne, La Montagne Sainte-Victoire vue des carrières de Bibémus, 1898-1900, olio su tela, 65x81 cm, The Baltimore Museum of Art.
Un uso della preistoria che prende forme molto diverse nel percorso della mostra…
All’approccio speculativo dell’ingresso segue l’inizio di storicizzazione nella prima sala della mostra, intitolata “Lo spessore del tempo”, che vuole dimostrare come la preistoria strettamente umana sia stata fondata sull’abisso del tempo. In altre parole, è impossibile separare la preistoria simbolica dalla geologia e dalla paleontologia, nelle quali l’uomo stesso è invischiato.
Sono Cézanne e Redon che c’introducono in questa “rivoluzione geologica”, nei confronti della, e in seguito alla, rivoluzione copernicana. Si tratta di due artisti per molti versi non comparabili, ossessionati dall’idea del tempo dilatato che si materializza negli strati geologici. Ma questa storicizzazione, supportata da documenti come i Carnets di Cézanne, non è in grado di esaurire le opere esposte.
Il nostro incontro fenomenologico con Dans les Carrières de Bibémus di Cézanne ripete, per l’ennesima volta, lo stesso “dramma” formulato in quest’opera: una figura minuscola intrappolata tra due pieghe geologiche, un uomo risucchiato nella vagina triangolare della terra. Resta aperta la domanda se Cézanne mettesse l’accento sullo scarto tra vita individuale e geologia o sull’esistenza necessaria di un soggetto affinché la geologia sia testata e conosciuta in quanto tale; in finale, è la tensione tra queste due interpretazioni che dà senso all’approccio immanentista di Cézanne.
![Vista della mostra Préhistoire. Une énigme moderne, Centre Pompidou, Philippe Migeat, 2019.]()
Vista della mostra Préhistoire. Une énigme moderne, Centre Pompidou, Philippe Migeat, 2019.
Proseguendo la visita c’imbattiamo, più o meno a metà percorso, in una sala con diverse vetrine che molti spettatori, me incluso, associano istintivamente ai musei di storia naturale, ovvero al modo in cui gli oggetti preistorici sono resi visibili e “culturalizzati” dal nostro sguardo.
Pietre intagliate, figure femminili e animali, blocchi incisi, disegni a inchiostro, calchi in gesso, acquerelli.... Ora, è solo leggendo le didascalie che notiamo, non senza sorpresa (l’enigma non è lontano) che sono di Picasso, Mirò, Matisse, Masson, Henri Michaux, Jean Arp, Giacometti, Louise Bourgeois, Joseph Beuys. Insomma, non siamo più in una preistoria scissa dalle nostre preoccupazioni ma nel cuore palpitante della modernità.
Se le due temporalità restano in finale incommensurabili, qui il confronto è ravvicinato: c’è una corrispondenza tra le diverse morfologie che rasenta il mimetismo. Che questa sala mostri il fascino della modernità per la preistoria è ovvio. Forse suggerisce qualcosa di più sull’enigma della preistoria in quanto, per riprendere le tue parole, “oggetto della coscienza occidentale”.
In effetti l’ambivalenza creativa è senza dubbio massimizzata nella stanza a cui ti riferisci, dove coesistono sculture moderne e sculture preistoriche – le cosiddette Veneri e gli animali scolpiti su ossa o pietra. Abbiamo voluto evitare il rischio di fare della preistoria una delle tante fonti cui gli artisti avrebbero attinto (che in fondo non spiegherebbe nulla), evitando i confronti letterali e la giustapposizione all’interno della stessa vetrina di opere appartenenti alle due epoche.
Da un lato abbiamo esposto documenti, in particolare disegni di opere paleolitiche della mano di Moore, Giacometti, Bonnard e così via che attestano l’oggettività di questo incontro; dall’altro, abbiamo creato uno spazio di risonanza in cui le sculture possono sottrarsi alle rigide periodizzazioni al cui interno la nostra disciplina tende a confinarle.
Quello che accade in questo spazio è l’incontro dei moderni con la preistoria nel tempo presente. Perché se c’è una differenza radicale tra la preistoria e altre epoche o culture che possono aver interessato gli artisti moderni desiderosi di liberarsi dalla norma del classico, è proprio il potere di presentificazione insito nelle opere della preistoria. Questi manufatti, d’origine universale, non essendo legati a culture locali e indigene (mi riferisco qui al Paleolitico), quanti gli conferisce un supplemento antropologico, si sono conservati per migliaia di anni nei sedimenti della terra prima di emergere improvvisamente nel presente, pur conservando intatta la loro forza di un’origine antichissima, sebbene sempre incompleta, lacunare, enigmatica.
Presentificare
Non insisteremo mai a sufficienza sul potere e la presenza delle opere preistoriche, soprattutto quando legati alla loro capacità di de-familiarizzare lo sguardo. Un doppio carattere che chiarisce forse l’enigma che ci preoccupa. Questa presentificazione – o questo “effetto di presenza” come direbbe Hans Ulrich Gumbrecht – costituisce, come suggerisci, la specificità della preistoria rispetto al primitivismo in quanto forza creativa per gli artisti.
Mi piace pensare che le forme simboliche della preistoria abbiano mantenuto, nonostante il processo di secolarizzazione e storicizzazione che è all’origine stessa della loro scoperta, quel carattere di “fulmine” – improvviso, istantaneo e sempre inspiegabile – che si attribuiva alle “pietre da fulmine”, come venivano chiamate le selci prima dell’invenzione della preistoria. In un certo senso, chiunque entri in questa sala rievoca l’incontro degli artisti moderni con la preistoria.
È il motivo per cui questa sala funziona in un primo momento nel suo complesso, e solo in seguito sollecita l’attenzione dello spettatore su questa o quella forma individuale. Ci chiniamo quindi per adattare il nostro corpo alla scala della preistoria, spesso minuscola, cosa che accade più raramente con le opere dei moderni, con l’eccezione significativa di Giacometti.
Il cambio di scala opera con la moltitudine di forme e tecniche: la Venere readymade di Mirò e di Picasso, l’intreccio dei tempi dello stesso Picasso, le traduzioni più fedeli di Brassai e Louise Bourgeois. Multipla, lacunare ed enigmatica, la preistoria ha avuto una forza di de-familiarizzazione dello sguardo che non è paragonabile a quella del primitivismo, perché passava principalmente attraverso la coscienza soggettiva del tempo. Da qui la grande eterogeneità delle forme moderne a cui ha dato origine, spingendosi spesso ben oltre la somiglianza letterale e ritornando nel corso della lunga modernità con una regolarità inesauribile.
![Pablo Picasso, Buste de femme, Boisgeloup, 1931, gesso, 62,5 x 28 x 41,5cm, Musée national Picasso-Paris.]()
Pablo Picasso, Buste de femme, Boisgeloup, 1931, gesso, 62,5 x 28 x 41,5cm, Musée national Picasso-Paris.
Immagino che avete riflettuto molto sul modo migliore di rendere visibili i manufatti preistorici che cadenzano Préhistoire. Un énigme moderne e vorrei saperne di più.
Secondo una museografia che ha fatto il suo tempo ma è ancora molto diffusa, questi manufatti sono generalmente classificati per tipologia e accatastati in grandi vetrine. C’è poca attenzione per la loro singolarità e per la loro esposizione. Al contrario, quando si utilizzano nuove tecnologie, la massa d’informazioni e la proliferazione di schermi rischia di smaterializzare il manufatto in questione. Come se la sua sovra-esposizione coincidesse in qualche modo con la sua scomparsa.
Ora, quello che mi ha colpito in Préhistoire. Un énigme moderneè l’attenzione verso questi manufatti: il cranio di Cro-Magnon già citato, le pietre antropomorfe, i legni di forma e fattura diverse, le statue e le lastre, le figure femminili tra cui la straordinaria Venere di Lespugue (che ritroviamo alla fine della mostra in un video di Allora e Calzadilla)...
![Bloc gravé figurant un cheval, verso -15000 anni, pietra calcarea incisa, 28 x 23,4 x 5,4 cm, Musée d’archéologie nationale – Domaine national de Saint Germain-en-Laye.]()
Bloc gravé figurant un cheval, verso -15000 anni, pietra calcarea incisa, 28 x 23,4 x 5,4 cm, Musée d’archéologie nationale – Domaine national de Saint Germain-en-Laye.
Senza sovra-esporli, questi manufatti mantengono intatto il loro carattere enigmatico, tanto più sorprendente in quanto, come hai appena ricordato, si esercita su oggetti di piccole dimensioni. Certo, il rischio di trasformarle in opere d’arte è sempre presente – ed è difficile, credo, evitarlo completamente quando si passa dall’antropologia alla storia dell’arte – ma il dispositivo che avete scelto ha il vantaggio di lasciar spazio agli effetti di presenza. Che sia esattamente questo lo sguardo adottato da alcuni artisti moderni nei confronti dei manufatti preistorici?
Se è legittimo parlare di incontro tra preistoria e modernità è proprio perché c’è una de-familiarizzazione e uno sfasamento reciproci. Non mi riferisco qui al celebre “orizzonte d’attesa” che determina inevitabilmente ogni creazione. Penso piuttosto alla reciprocità intrinseca all’“invenzione moderna della preistoria” stessa. Mentre la nostra modernità era alle perse con l’accelerazione industriale, mentre cercavamo di fuggire da noi stessi esplorando terre lontane, fino alla terra australe, abbiamo scoperto il tempo profondo che ci ha costituito, letteralmente e metaforicamente, nei sotterranei europei.
Questa invenzione ci offriva sia l’estraneità di cui avevamo bisogno, sia l’affinità che ci ha permesso di identificarci più facilmente con i nuovi oggetti e le soggettività che implicavano.
Per parlare più precisamente dell’installazione, l’esposizione di manufatti preistorici in un museo d’arte moderna accentua naturalmente la loro forza di presentificazione e, come ho detto, ripete la serie d’incontri del moderno con la preistoria. Prendiamo la Venere di Lespugue, rotta accidentalmente dall’operaio che l’ha trovata nel 1922. Questa rottura ha rivelato la bianchezza originale dell’avorio, visto e lavorato dallo sconosciuto che ha inciso la figura femminile. Questa bianchezza contrasta fortemente con la superficie della scultura molto annerita a causa del sotterramento protrattosi per 25.000 anni nei sedimenti della terra.
![Venere di Lespugue, verso - 23 000 ans, avorio di mammouth, 14,7 × 6 × 3,6 cm, Musée de l’homme, Paris.]()
Venere di Lespugue, verso - 23 000 ans, avorio di mammouth, 14,7 × 6 × 3,6 cm, Musée de l’homme, Paris.
È così che la lunga durata – inestricabilmente geologica e archeologica – dell’avorio annerito e in qualche modo restituito alla mineralità si articola nel presente del bianco iniziale. Ma attenzione: questo presente è in modo indissolubile quello dell’artista e degli spettatori contemporanei. Il tempo è abolito, si piega fino a che le sue due estremità si toccano.
È significativo, al riguardo, un commento ricorrente quando parlo coi visitatori della mostra, il loro desiderio di tornarci. Al di là delle ragioni che evocano, che non spetta a me menzionare, sono convinta che la ragione principale, consapevole o meno, sia in fondo che vorrebbero approfittare di questa eccezionale “uscita” della preistoria, di questa mise-en-abîme generata dall’incontro tra due epoche che si trovano alle estremità opposte del tempo.
Cosa importa se tutte queste opere sono ben visibili al Museo di Saint-Germain en Laye o al Musée de l’Homme? Il loro spostamento temporaneo in uno spazio dedicato alla modernità evidenzia e attiva la scena originaria – nelle sue innumerevoli ripetizioni – dell’invenzione della preistoria.
L’arte parietale e la grotta
Ho l’impressione che una modernità altra s’impone anche nella sala sull’arte parietale delle grotte del Paleolitico, dove gli enormi acquerelli su carta incollata dell’etnologo tedesco Leo Frobenius sono seguiti da Dubuffet e dalla Caverna dell’anti-materia di Pinot Gallizio.
Il caso di Frobenius è interessante: le sue immagini sono pubblicate in riviste d’avanguardia quali Cahiers d’art e Documents, pur prendendo le distanze dalle preoccupazioni dell’arte contemporanea, mosso solo da un intento scientifico.
In ogni caso, il fascino per l’arte parietale e i suoi graffiti attraversa tutto il Novecento: quest’arte offre un modello artistico che va oltre la tradizione del quadro da cavalletto; più radicalmente, riattiva la quête dell’origine, dell’attività artistica e dello stesso essere umano, e induce a negoziare il rapporto tra il minerale e il vivente. Luogo d’elezione degli speleologi, la grotta influenza l’immaginario degli artisti. Diventa una time capsule che ha forse lo stesso ruolo della Domus aurea per gli artisti del Rinascimento italiano, con le sue grottesche...
![Vista della mostra Préhistoire. Une énigme moderne, Centre Pompidou, Philippe Migeat, 2019.]()
Vista della mostra Préhistoire. Une énigme moderne, Centre Pompidou, Philippe Migeat, 2019.
C’è in effetti qualcosa di sorprendente nella scoperta accidentale della Domus Aurea al Rinascimento, e la metafora della “capsula del tempo” che evochi è al proposito pertinente. Sto leggendo le interessanti riflessioni di Michel Julien nel suo ultimo saggio intitolato Les Combarelles sulle grotte come “capsule del tempo”, che avvicina al “Golden Record” inviato dalla NASA nel 1977 nello spazio a bordo del Voyager 1 e 2, su cui erano state incise parole in diverse lingue, versi di Omero o musica di Bach, indirizzati a esseri sconosciuti.
![Vista della mostra Préhistoire. Une énigme moderne, Centre Pompidou, Philippe Migeat, 2019.]()
Vista della mostra Préhistoire. Une énigme moderne, Centre Pompidou, Philippe Migeat, 2019.
Tuttavia, c’è una grande differenza tra le “capsule del tempo” della preistoria e quelle dell’antichità greco-romana, ovverosia l’assenza di qualsiasi scrittura in senso stretto che è specifica alla preistoria. Non solo l’antichità greco-romana aveva un valore normativo, ma le scoperte archeologiche successive iniziate nel Rinascimento si sono sempre dovute misurare a un testo preesistente. Sebbene ogni rivelazione eminente abbia qualcosa di sorprendente, perché abolisce il tempo che separa noi, i viventi, dagli oggetti realizzati molto tempo fa dai nostri simili, le grotte della preistoria hanno rivelato – e continuano a farlo – quello che non eravamo pronti ad aspettarci.
La modernità ha rinvenuto nella preistoria una fonte di sorpresa, di de-familiarizzazione permanente, una terra sconosciuta, che non è dell’ordine della res extensa cartesiana e non può essere colta o interamente dominata, ma che è interna e in gran parte immaginaria.
Politica del Neolitico
L’interesse per i fossili durante la prima guerra mondiale; l’enigma coltivato dai surrealisti negli anni 30; l’acquerello di Klee del 1933; il rapporto Hiroshima-Lascaux; l’interesse per le grotte in piena minaccia nucleare; la riabilitazione della geologia all’epoca dell’Antropocene: la preistoria non è tagliata fuori, come si potrebbe pensare, da questioni politiche. Per dirlo con una battuta di Robert Smithson: “M’interesso alla politica del periodo Triassico”!
L’uso politico della preistoria è particolarmente evidente nel Neolitico, dove entrano in gioco questioni identitarie; la quête dell’origine diventa uno strumento per legittimare se non per rivendicare un’eccezione culturale nazionale…
In effetti anche se il Paleolitico è stato ed è ancora politicizzato, in particolare come modello anarchico originario (dall’anarchia pacifista e naturalista di fine Ottocento al pensiero anti-statale di antropologi quali Claustres, Sahlins e Scott di oggi), il Neolitico ha permesso una politicizzazione più marcata attraverso due proprietà, talvolta antitetiche, che gli sono state attribuite. Queste due proprietà sono la nozione di “rivoluzione” e quella di “radicamento”. La “rivoluzione neolitica”, enunciata molto presto dai paleontologi, implicava una differenza radicale di quest’epoca rispetto al Paleolitico, uno “iato” come si diceva allora. Una differenza che è tecnica, economica, politica e culturale. In un certo senso, le forme chiare e levigate del Neolitico esprimono di per sé l’allontanamento della specie umana dal suo rapporto inestricabile con l’ambiente naturale e con l’animalità. La “rivoluzione” diventava una metafora appropriata perché si consumava una rottura col passato, ma anche perché, a partire dall’addomesticamento del mondo da parte dell’uomo, il progresso si metteva in moto. Un’ideologia adatta agli evoluzionisti di destra come di sinistra.
Contemporanea alla metafora della rivoluzione è quella del radicamento. Paleontologi e storici credevano che dal momento in cui le società umane mettevano radici in un luogo, cominciava la storia nazionale. E se consideriamo che la maggior parte delle strutture megalitiche si trovano nel Nord Europa, cogliamo facilmente la divisione tra un Sud Paleolitico, naturalistico e sensuale, e un Nord Neolitico, astratto e metafisico, operato da paleontologi e da storici dell’arte.
Le due metafore si sono congiunte e hanno trovato una perspicacia nefasta durante gli anni del fascismo. Infatti la “terza via” si proiettava perfettamente in questo Neolitico, considerato sia come un salto tecnico che come un popolo radicato nella natura. I modernisti britannici degli anni Trenta hanno trovato nelle forme astratte e radicate dei monumenti megalitici le forme originarie delle proprie creazioni, sforzandosi di riconciliare astrazione tecnica e autoctonia, universalismo e particolarismo.
La preistoria all’epoca dell’Antropocene
Visitare una mostra come degli speleologi, far esperienza della mise-en-abîme propria all’enigma della preistoria: oggi viviamo sulla nostra pelle un turbamento temporale, divisi come siamo tra il tempo profondo, l’accelerazione del presente e le diverse versioni d’avvenire a nostra disposizione, dal futuro minacciato dall’azione umana al futuro d’evasione offerto dalla science-fiction e dalla realtà aumentata.
Fai bene ad associare il lungo periodo della preistoria all’accelerazione del presente – la sensazione, analizzata per la prima volta da Reinhart Koselleck, di una transizione eterna, tagliata fuori dall’esperienza del passato e priva di fiducia nel futuro. Ma è proprio questa rottura a stimolare la concezione e la realizzazione di un passato così lontano da essere stato dimenticato e che, proprio per questo motivo, si carica del potenziale del “nuovo” che si attribuiva esclusivamente al futuro ignoto. Il tempo lungo del passato, inoltre, associato soprattutto all’immaginario geologico e paleontologico, si proietta anche nel futuro, altrettanto distante, altrettanto stupefacente e in fondo così vicino alla preistoria.
Prendiamo il famoso esempio della Time Machine di H.G. Wells: la proiezione in un futuro immensamente remoto rivela una realtà simile a quella del passato preistorico, ma in cui il rapporto tra esseri umani e animali è invertito. In questa narrazione fondatrice sono gli esseri umani, rappresentati come quegli “esseri soddisfatti” che l’hegeliano Kojève situava alla fine della storia, a diventare oggetto di sacrificio di esseri mostruosi che vivono nel mondo sotterraneo. Questa stessa rappresentazione di un tempo reversibile si ritrova più tardi in molti autori di fantascienza (Ballard, Aldiss, ecc.) così come in Georges Bataille che speculava su Lascaux sotto l’impatto di Hiroshima.
Inoltre, se il “sentimento della preistoria” (l’espressione è di Giorgio de Chirico) è oggi così potente, è perché la nostra storicità si proietta facilmente in questo periodo, dotato più d’ogni altro di una forza temporale ambivalente – assieme apocalittica e creativa – in virtù della sua estensione e del suo carattere enigmatico. Così ci sforziamo di rappresentare noi stessi come degli agenti geologici, per assumere la responsabilità storica e politica che ci appartiene in quanto abitanti e utilizzatori del pianeta Terra. Ma, allo stesso tempo, cerchiamo nella preistoria della nostra specie un potenziale utopico. Da qui un maggiore interesse per il Paleolitico a scapito del Neolitico che viene spesso interpretato come l’età della costrizione, o come l’inizio della fine (il libro di James C. Scott Homo domesticus. Une histoire profonde des premiers Etatsè sintomatico al riguardo).
Insomma questa scena dell’invenzione moderna della preistoria, questa “uscita dal tempo” si è verificata più volte nel corso del XX secolo. Lo stesso vale per l’esposizione della preistoria in un museo d’arte moderna, un evento raro ma non unico.
Penso in particolare alla celebre mostra Prehistoric Rock Pictures in Europe and Africa voluta nel 1937 da Alfred Barr nel tempio del modernismo, il Museum of Modern Art di New York, o a Neo Preistoria. 100 Verbi di Andrea Branzi e Kenya Hara alla XXI Triennale di Milano nel 2016.
Che queste e altre esposizioni coincidano con un momento specifico nella fabbrica moderna della preistoria, per così dire? Che ognuna risponda a una specifica agenda artistica, culturale e politica? Che ci raccontino il modo in cui è evoluta la nostra attrazione per la preistoria, le nostre idee sul tempo e il ruolo dell’uomo nella storia e sul pianeta? Se l’ipotesi è ragionevole, in quale contesto s’inscrive il nuovo volet costituito da Préhistoire. Un énigme moderne? o, per dirlo altrimenti, come esporre la preistoria all’epoca dell’Antropocene?
Préhistoire. Un énigme moderne non è la prima mostra ad unire le due pagine evocate dal titolo. Herbert Read, che ha concepito con Roland Penrose 40000 Years of Modern Art (ICA, Londra) ha scritto, sotto l’influenza di Wilhelm Worringer, che l’ansia del rapporto dei moderni con la modernità tecnica li ha resi psichicamente simili agli uomini preistorici. Ciò che distingue la nostra mostra, tuttavia, è il suo sguardo profondo e storicizzante, che considera Read, Benjamin o Bataille in quanto oggetti storici alla stessa stregua degli artisti o dei paleontologi. Anche Walter Benjamin ricorreva all’analogia tra la prima natura della preistoria e la seconda natura della modernità, che esigeva tecniche diverse per l’addomesticamento del pericolo.
Più recentemente, Andrea Branzi ha definito il nostro tempo come una “neo-preistoria”, evocando il nostro procedere a tentoni nel buio, quell’incertezza che condividiamo con la preistoria. Salutare è il fatto che non c’è nulla di apocalittico in questa incertezza. Per Branzi, ogni volta che l’uomo ha varcato le soglie della sua lunga storia, ripeteva in sostanza la preistoria. Dopo la certezza del “progetto” modernista, ritroviamo così il rapporto con il dubbio.
Da parte mia, ho l’impressione che da una ventina d’anni almeno tendiamo a sottolineare eccessivamente il lato trionfale del modernismo, a scapito di un rapporto più sfumato che lo stesso modernismo intratteneva col progresso. Non abbiamo il dono delle sfumature, della contraddizione e del dubbio. Lavorando a questo progetto, mi sono infine interessata ai tentativi concettuali e formali di pensare una modernità più agitata e contraddittoria, una modernità che, proprio nel momento in cui instaura un rapporto di dominio sulla natura, si scava, letteralmente e metaforicamente, la terra sotto i piedi.
Trouble temporale
Tocchiamo qui il cuore della nostra conversazione sulla preistoria come enigma moderno. Visitando la mostra e leggendo il catalogo, mi sono reso conto che gli artisti non hanno reagito in modo univoco. Secondo Mirò, l’arte è in declino sin dai tempi della preistoria; per Picasso, gli artisti non hanno fatto niente di meglio sin da allora; Giacometti perde ogni fiducia nell’idea di progresso, ecc.
Per semplificare, distinguo: a) chi pensa che l’arte sia in decadenza fin dalla preistoria, che l’apice della produzione artistica sia raggiunto fin dal suo inizio; b) “il futuro non è più quello di una volta” (secondo lo scrittore di science-fiction A.C. Clarke): la preistoria e il tempo profondo modificano non solo le nostre idee sul passato e il nostro rapporto col presente ma anche la nostra capacità di immaginare il futuro.
Tuttavia a) è una posizione che, pur tenendo conto della profondità del tempo, rimane classica: la storia è un progressivo allontanamento da una Tradizione perfettamente compiuta e non più raggiungibile dai Moderni. Una posizione che si limita, in finale, a invertire la freccia ascendente del progresso, mantenendo intatta la linearità della storia.
b) mi sembra molto più promettente, legata al passo di Bataille che hai citato (qui come in altri articoli che ho letto, in particolare su Pierre Huyghe), dove Lascaux e Hiroshima si attraggono, si assomigliano, si invertono, entrano in una corrispondenza anacronistica, formano un nodo o un cronotopo concettuale esplosivo. Che questa strada ci permetta di rendere più complessa la modernità stessa?
Tra l’altro, mi chiedo come ripensare Bataille – e l’enigma – oggi che si visita una riproduzione in scala 1:1 della grotta di Lascaux mentre l’originale è ormai inaccessibile.
Ci sono ovviamente diverse concezioni della storia che coesistono all’interno della modernità. I conflitti non sono solo tra questa o quella tendenza, ma spesso operano anche all’interno dello stesso pensiero. Da parte mia, ho sempre trovato nei pensieri contraddittori (Bataille, Carl Einstein, Benjamin e molti altri) quelle scintille che illuminano in modo inaspettato gli oggetti che mi sforzo di comprendere.
Non sono sicura di capire cosa vuol dire “anacronismo” – a infastidirmi è il fatto che presuppone, come antitesi, o un pensiero essenzialista e lineare o una storia chiusa e omogenea. Ma, da una parte, queste forme di storicità hanno raramente quel carattere esclusivo e puro che gli viene attribuito e, dall’altra parte, non sono realmente maggioritarie nel pensiero storico della modernità.
Possiamo anche ribaltare la domanda: è vero che Mirò aveva detto che la pittura era in declino fin dall’età delle caverne, ma questa non è l’altra faccia della medaglia del progresso? Al contrario Mondrian, che non ha mai cessato di evocare il progresso e la fine dell’arte e che viene spesso considerato come un modernista hegeliano, ha fatto di tutto per evitare che questa fine accadesse, sapendo fin troppo bene che lo spazio proprio dell’arte era quello della tensione del tragico.
Le cose sono quindi più complicate di quanto la doxa modernista e postmodernista ci ha insegnato. È indubbiamente utile sbarazzarsi di modelli diventati troppo familiari per pensare la modernità. Il lavoro di de-familiarizzazione è infinito! Del resto, da parte mia, non ho problemi con la denominazione dei “moderni”, a patto che con questo termine non s’intenda solo una mentalità e un atteggiamento conquistatore, eudemonico e, in ultima analisi, ingenuo. Ernst, Klee, De Chirico, Picasso, Mirò, Oldenburg, Morris o Smithson sarebbero stati anti-moderni se non avessero adottato una credenza plateale nel progresso? Perché ricorrere a un dualismo così marcato per comprendere le dinamiche della lunga modernità?
Lentezza e accelerazione, tempo lungo e proiezione nel futuro, malinconia e mania, sentimento precario e proiezione nella durata: i diversi modi di tensione possono rivelarci in effetti una modernità diversa da quella che oggi, come penitenti, prendiamo gusto a condannare. Ed è questa modernità che può aiutarci a capire cosa ci sta accadendo oggi.
Scala geologica
Un’altra modernità o una modernità altra mi riporta a Robert Smithson, un artista radicato nella cultura americana ma con una sensibilità profondamente europea. Invece di adottare una posizione semplicistica che rifiuta il modernismo o, secondo una famosa affermazione di Donald Judd, l’arte europea in blocco, opera una mossa inaspettata: estende la cronologia artistica su scala geologica. Lo vediamo bene nella selezione delle sue opere in Préhistoire. Un énigme moderne: il film Spiral Jetty, il collage pop Venus with Reptiles (1963), la finzione geologica Strata, un racconto che alterna fotografia e scrittura.
Se oggi in Francia Smithson è al centro del dibattito critico, questo è forse dovuto anche a un disagio nei confronti di quelle narrazioni schematiche ereditate dal modernismo da cui tu prendi chiaramente le distanze.
L’esempio di Smithson è molto interessante per la sua spaventosa coerenza! Da una parte, ha condotto una critica molto rigorosa del modernismo essenzialista che si era affermato negli Stati Uniti sin dal secondo dopoguerra e, dall’altra, ha elaborato un suo sistema di rappresentazione attingendo agli universi più eterogenei che spaziano dalla cultura popolare alla letteratura e alla filosofia colta, passando per le scienze esatte e le scienze umane, in particolare nella loro declinazione strutturalista. C’è un certo pathos nel suo pensiero, nei suoi earthworks e nella sua scrittura; il suo universo era fondamentalmente pessimista, ossessionato da figure quali Pascal, Beckett, Borges o T.S. Eliot.
Ma in questi scrittori aveva trovato anche la dimensione “immaginaria” che allontanava il suo pessimismo e legittimava la vita. La scala geologica, che Smithson ha concepito e meticolosamente attivato nelle sue fotografie, opere e testi, ha funzionato come sostituto della storia e delle sue contraddizioni. È probabilmente questo aspetto del suo pensiero che mi dà più fastidio. Ma Smithson aveva stabilito la sua genealogia “moderna”: avendo compreso o letto in Meyer Schapiro il tropismo geologico di Cézanne, per la stessa ragione s’inscriveva egli stesso in questa tendenza. Il personaggio minuscolo stretto tra le due pieghe in Carrières de Bibémus di Cézanne diventa una macchia bianca alla fine della Spirale ripresa dall’alto: Smithson che corre sul pontile diventa una pietra tra le altre.
Da un abisso all’altro
Smithson era attratto dalla preistoria come dalla science-fiction, e forse vedeva queste due dimensioni compenetrarsi una nell’altra parte di un tempo senza l’uomo ai tempi della minaccia nucleare. Catene di pensieri che mi fanno pensare che Préhistoire. Un énigme moderne si apre mentre si festeggia il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla luna. È forse inevitabile, nel concludere la nostra conversazione sull’enigma moderno della preistoria, evocare lo spazio siderale. Passiamo così da un abisso all’altro...
Sì, uno dei momenti parossistici dell’invenzione moderna della preistoria risale all’ingresso nell’era atomica, epoca dotata di due facce opposte, quella distruttiva di Hiroshima e quella, considerata positiva, della conquista dello spazio. Abbiamo già accennato alla simmetria tra Lascaux e Hiroshima che è, credo, alla base del pensiero di Bataille sulla preistoria. Questo pensatore, che aveva elaborato una storia informe e contingente durante gli anni Venti, ha cominciato a concepire una storia molto più chiara, molto più univoca in seguito al disincanto delle “comunità acefale” come risposta al fascismo e allo scoppio della guerra. La sua concezione diventò hegeliana attraverso Kojève, spingendosi fino a immaginare una storia universale, ossessionata dall’idea della fine. Questa fine era stata indicata da Hiroshisma, un evento inaugurale di cui gli uomini non avevano le chiavi interpretative e che subivano passivamente come se fossero tornati allo stato animale.
Tra gli artisti, Lucio Fontana ha subito legato la preistoria, che assillava la sua immaginazione almeno sin dalla fine degli anni Trenta, ai viaggi interplanetari e al mondo inospitale della Luna. Il suo ambiente nero, nel 1949, fu interpretato come uno spazio preistorico; il suo scopo era quello di condurre lo spettatore a sperimentare l’estraneità, l’inadeguatezza degli uomini verso la nuova era che si profilava. Questo spazio intermedio, con sculture dai caratteri antidiluviani, non appartenenti a specie note né a regni naturali determinati e ben compartimentati, riattivava per l’ennesima volta l’età della preistoria.
Il primo uomo sulla Luna era dopotutto un primo uomo che provava un’ansia metafisica nello spazio minerale che stava calpestando. Altri artisti, come Frederick Kiesler e Pinot Gallizio, hanno creato degli ambienti rivisitando l’immaginazione della grotta. La grotta funzionava non solo come riparo dall’era atomica, ma anche come un luogo simbolico. Per Kiesler, la Endless House era un luogo di unità, di equilibrio tra materia e spirito e di uscita dal tempo a beneficio di un eterno presente e mitico, mentre per Gallizio la Caverna dell’antimateria rispondeva all’ideologia situazionista dell’attività gratuita, non utilitaristica, sciolta dal lavoro e dal valore di scambio. Anche lui esprimeva il desiderio di vivere un’esperienza piena del presente – senza la capitalizzazione del passato o la fuga nel futuro. Questo presentismo mitico costituisce un altro tratto, l’ennesimo, della preistoria inventato dopo la seconda guerra mondiale e la bomba atomica.