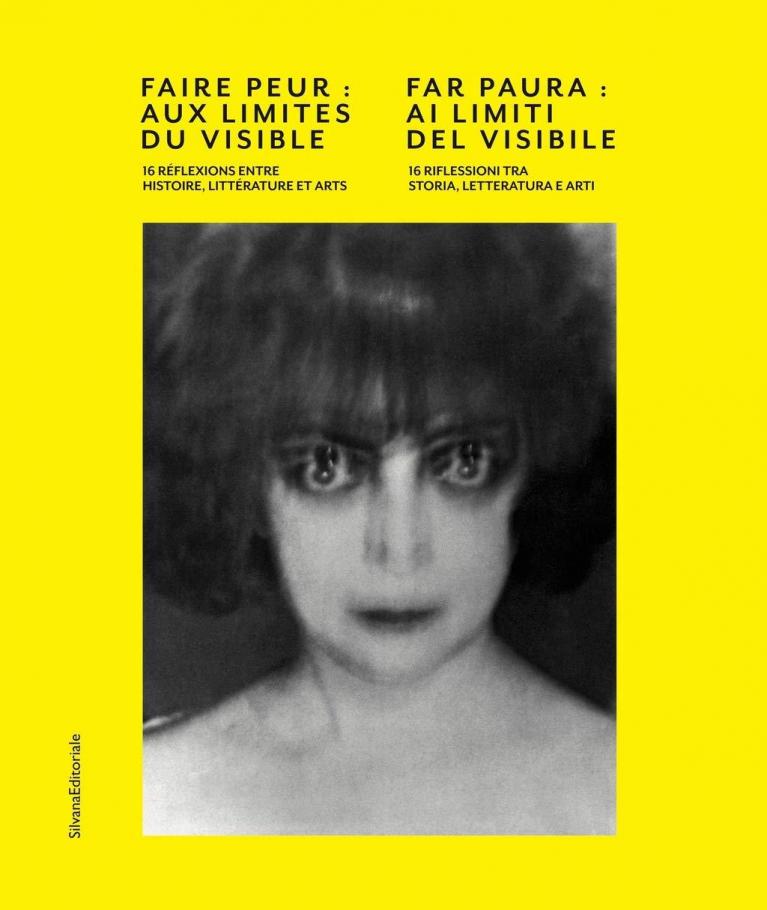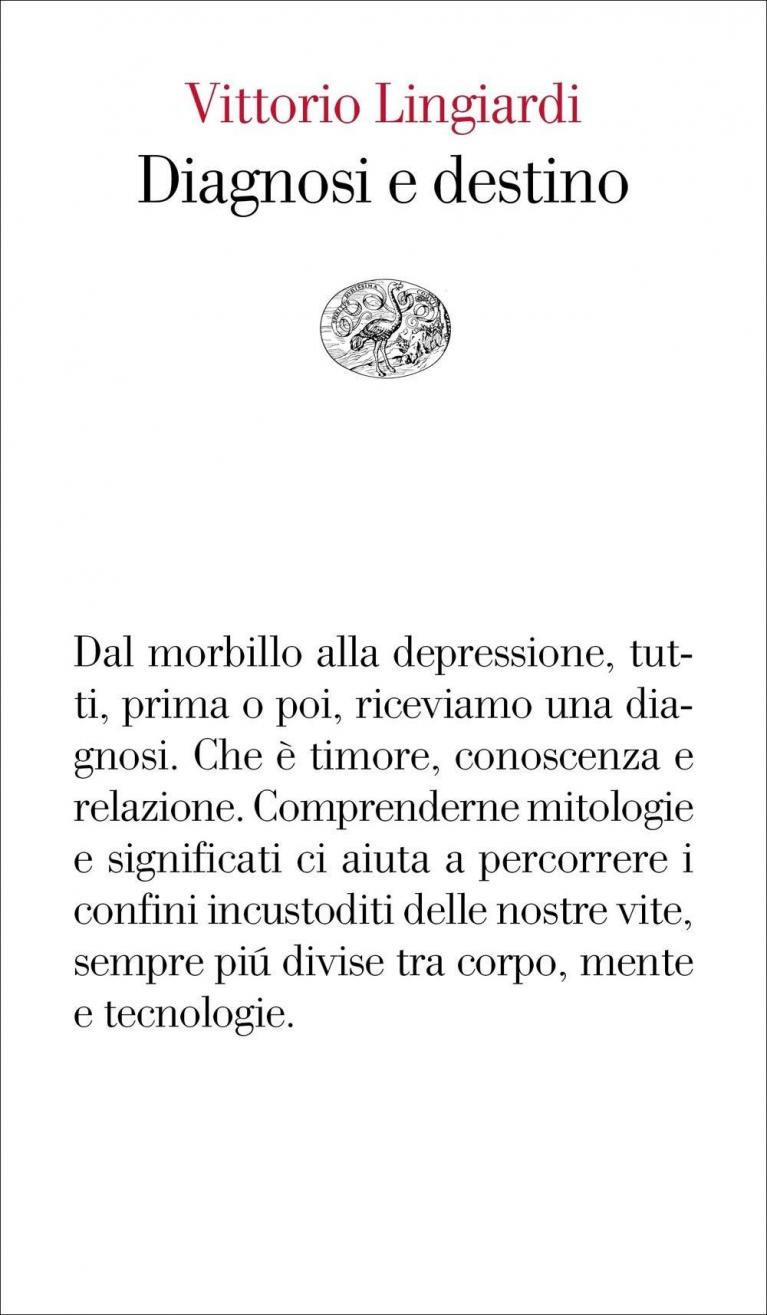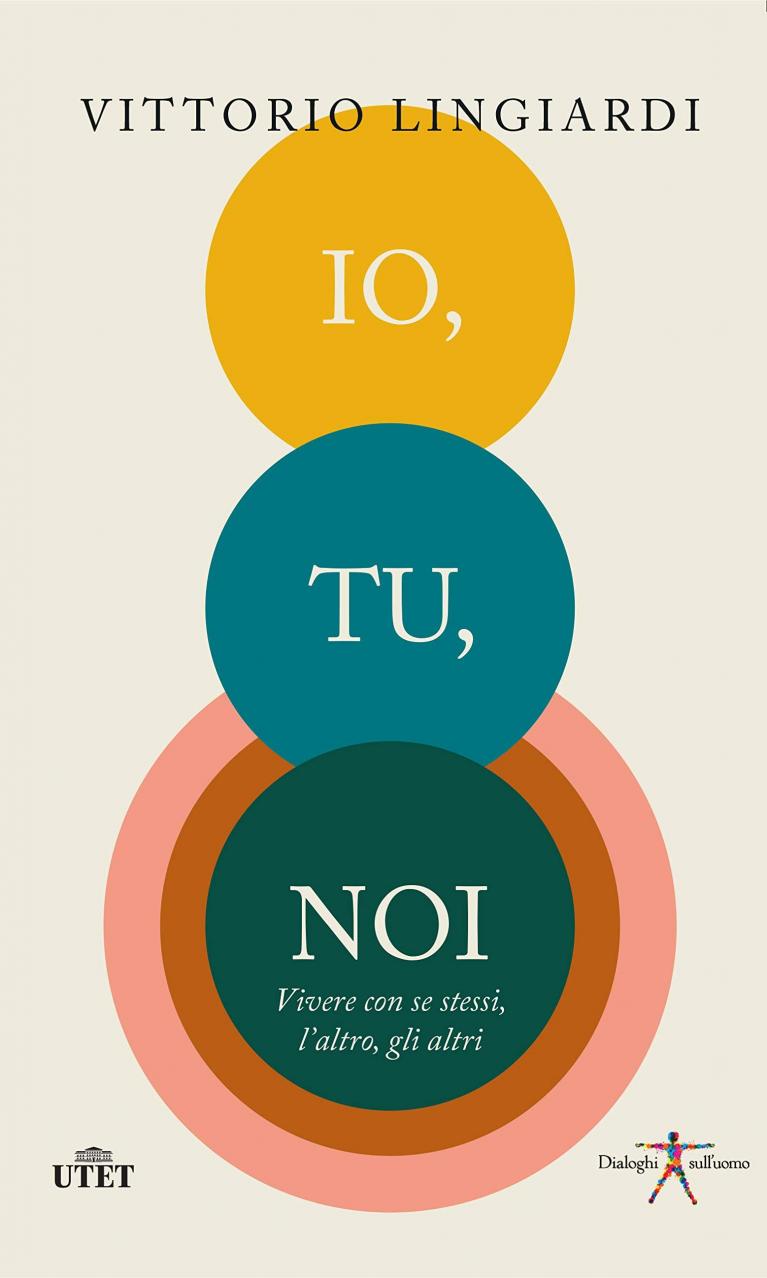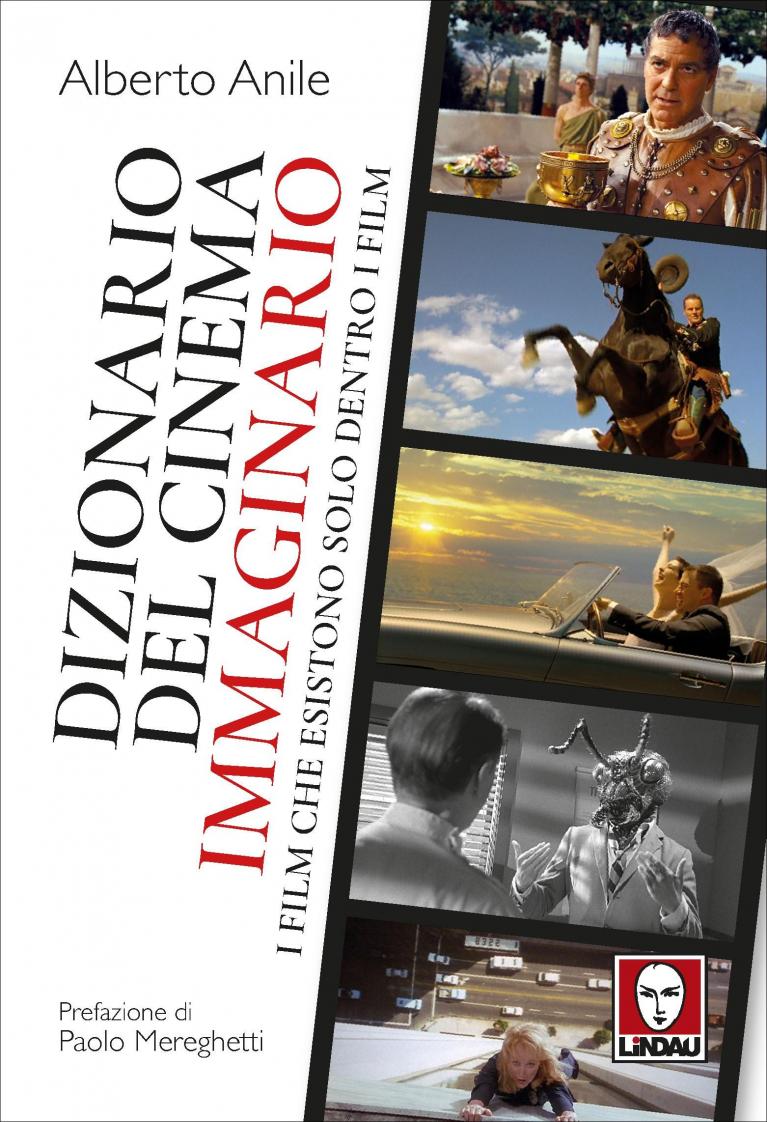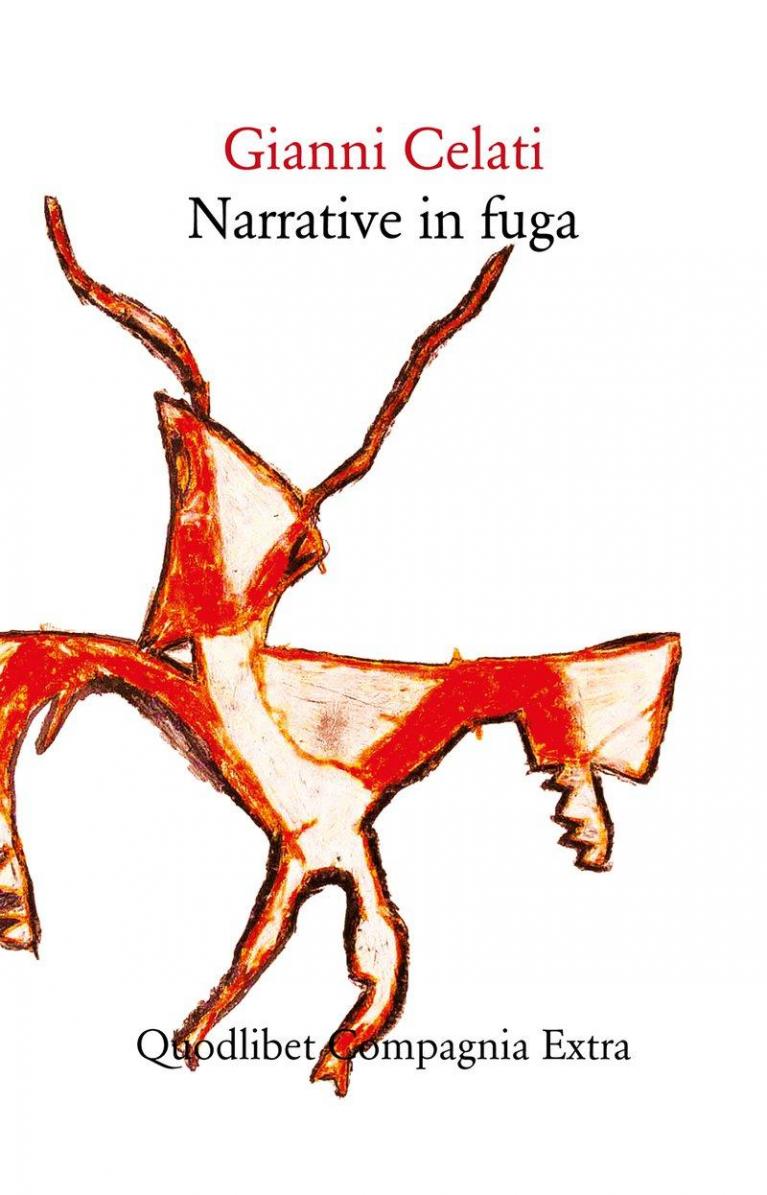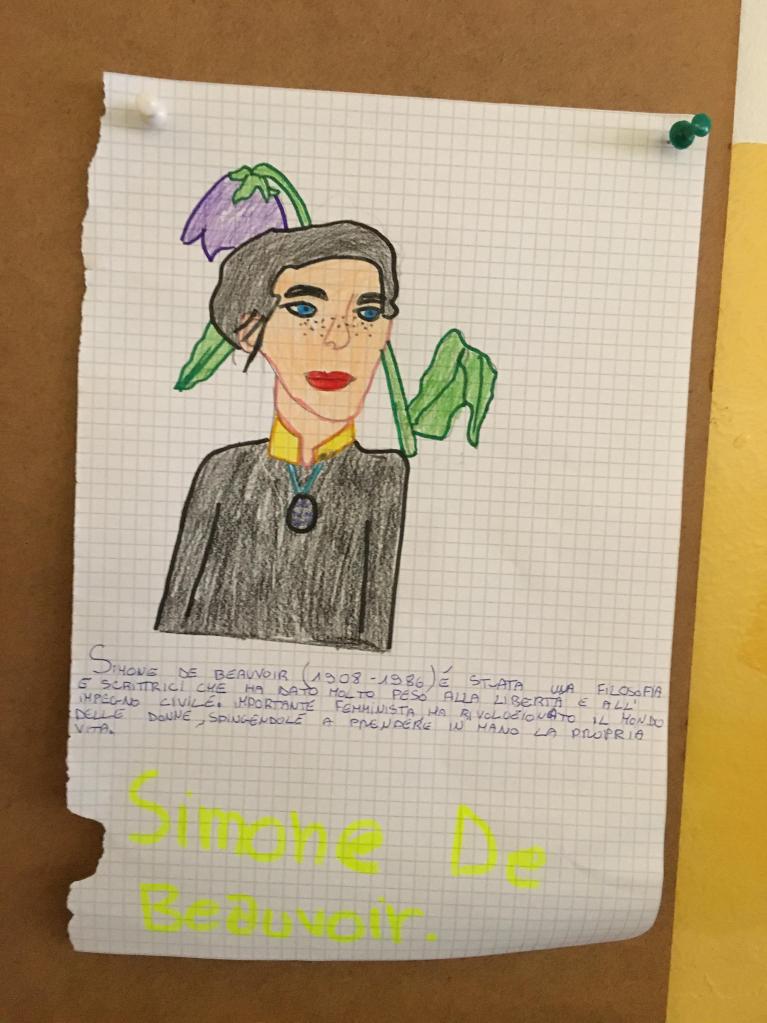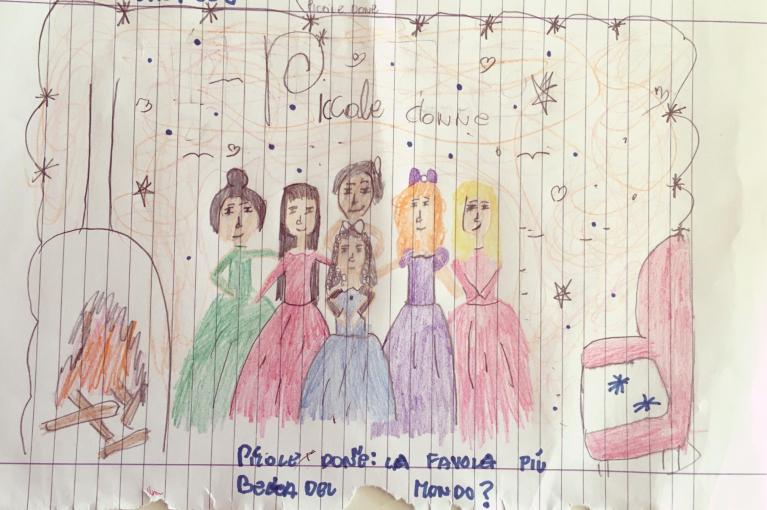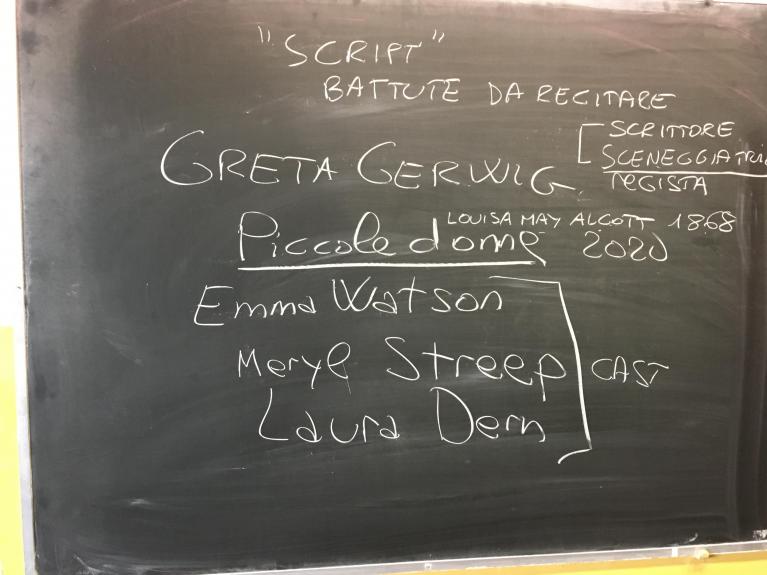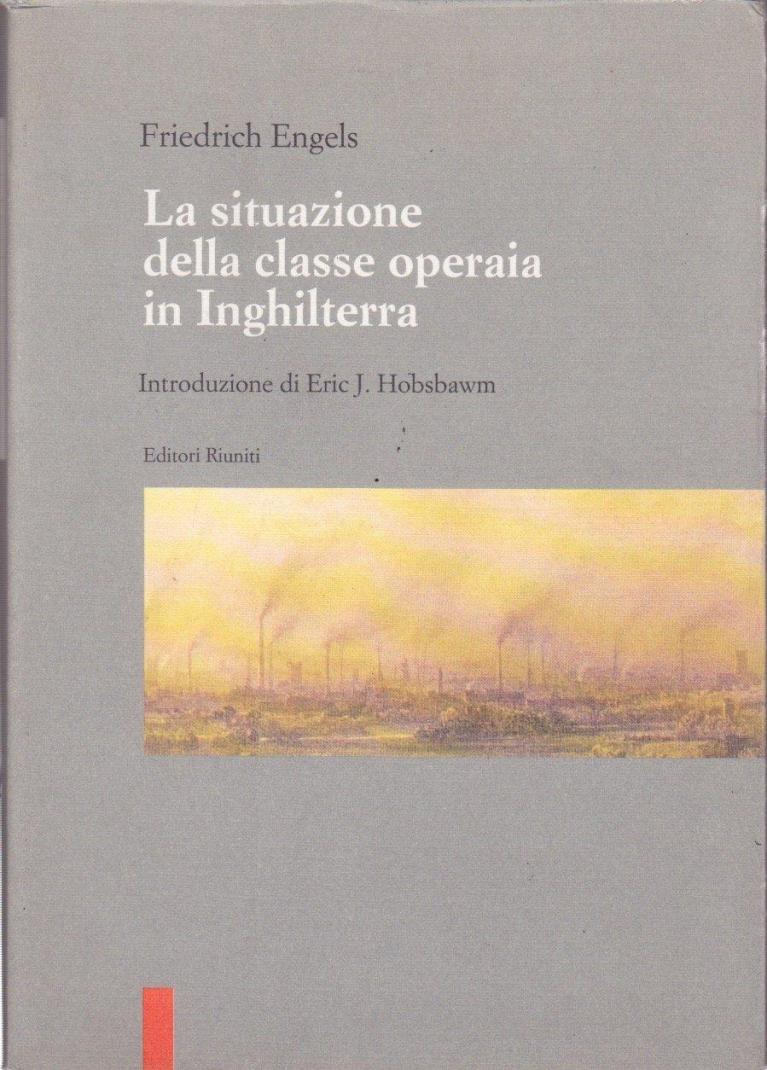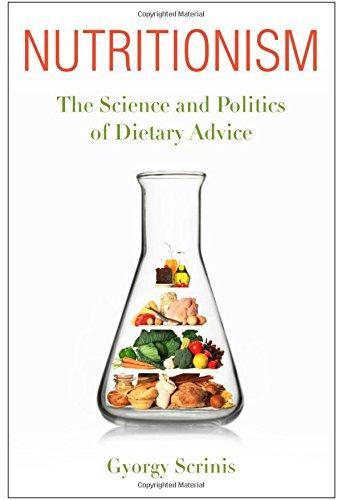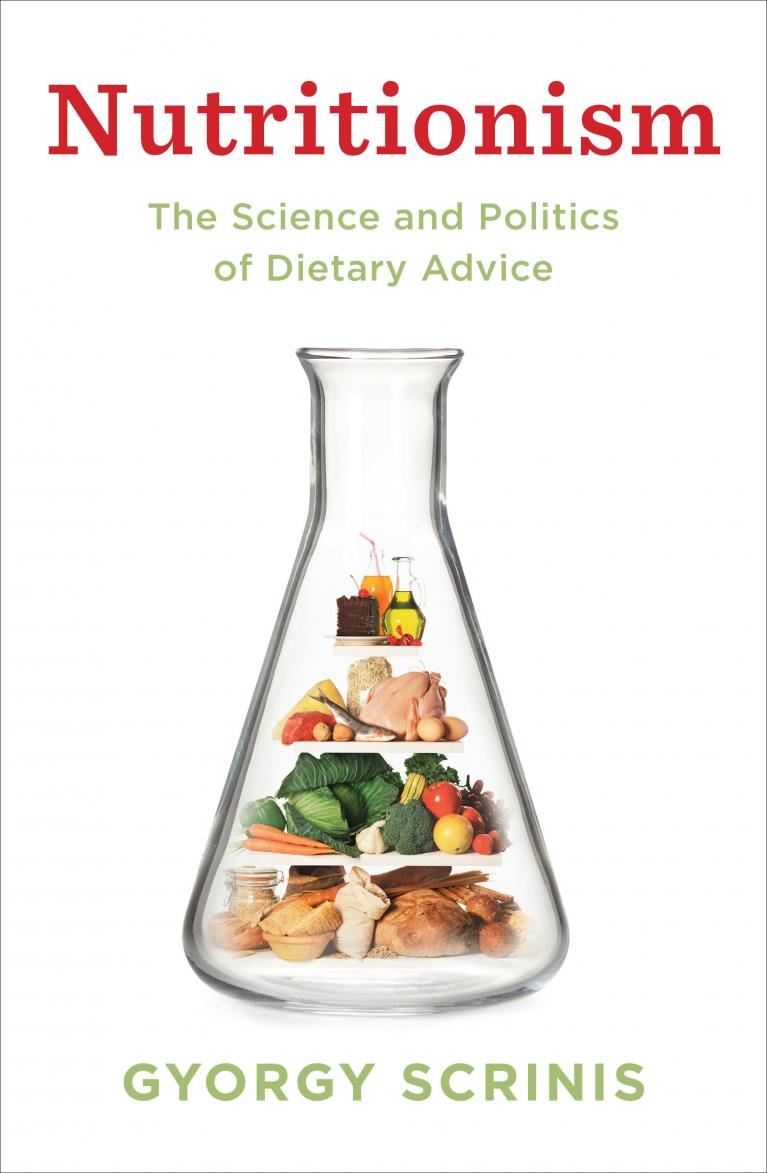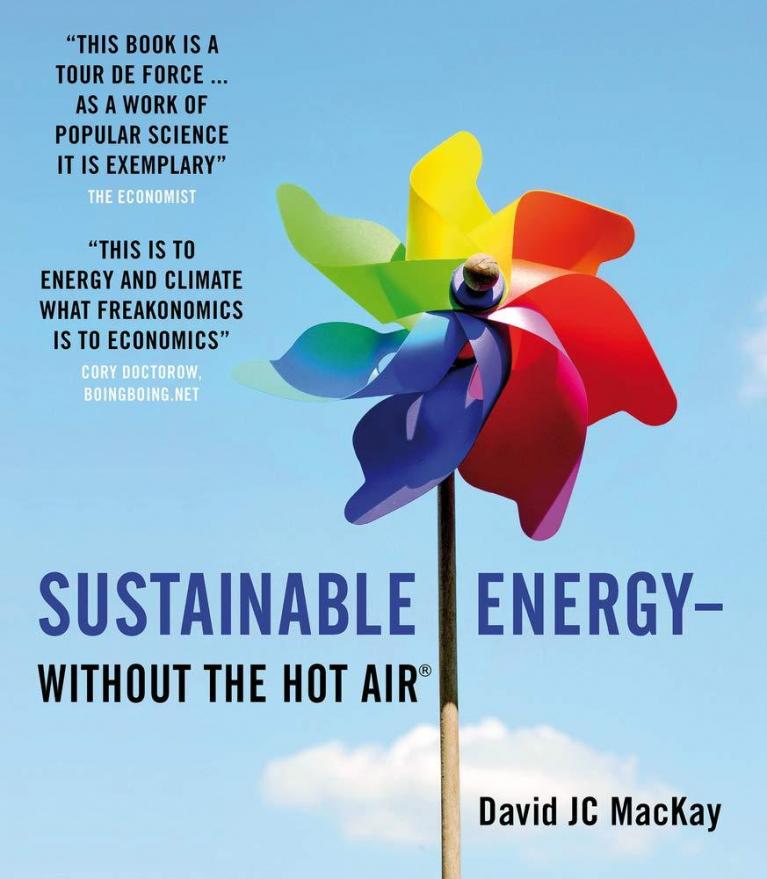In Sherlock Jr. (in italiano La palla n.13), diretto da Buster Keaton nel 1924, il proiezionista di un piccolo cinema di periferia, interpretato dallo stesso Keaton, cade addormentato durante un film e sogna di “entrare” letteralmente nel grande schermo. È la prima immagine che mi è venuta in mente sfogliando due libri pubblicati di recente: Una visita al Bates Motel di Guido Vitiello (Adelphi 2019, pp. 251, 38 euro) e il Dizionario del cinema immaginario compilato da Alberto Anile (Lindau 2019, pp. 328, 24 euro). Più che due libri “di cinema” si tratta di libri “cinefili”: due «capriole della visione», per dirla con Anile, due tuffi «negli abissi dello schermo». Entrambi nascono, mi sembra, dal desiderio di penetrare quasi fisicamente nel film, di abitarlo, di esplorarlo scena per scena, metro per metro.
![Buster Keaton, “Sherlock Jr.”, 1924.]()
Buster Keaton, “Sherlock Jr.”, 1924.
Detto questo, i due lavori sono profondamente diversi. Rispetto al volume Lindau, più modesto nella grafica e contenuto nelle dimensioni, quello targato Adelphi, sontuosamente illustrato a colori, è una festa per gli occhi: non solo un libro, ma anche un oggetto di pregio, come vuole la tradizione della casa (e in modo particolare della collana “Imago”, nella quale è pubblicato). Nella sua Visita, Vitiello, che insegna Teoria del cinema all’Università La Sapienza, sembra sfruttare il “paradigma indiziario” individuato da Carlo Ginzburg. Particolari all’apparenza trascurabili, poco più che casuali, molto spesso visibili a prezzo d’una più che attenta osservazione, si rivelano al contrario decisivi per individuare fenomeni più ampi: come, in questo caso, la visione del mondo di un regista (gli appassionati di coincidenze non potranno fare a meno di notare come “Imago” si sia aperta nel 2015 con un volume di Ginzburg). Proprio da uno di questi lapsus Vitiello incomincia la propria indagine intorno più famoso film di Alfred Hitchcock, Psycho.
Novello Auguste Dupin, l’autore individua la propria “lettera rubata” in un articolo dell’Hollywood Reporter del 10 giugno 1959, in cui si annunciava che Hitch era al lavoro su un nuovo progetto: «Hitchcock to Film “Psyche”», era il titolo. Avete letto bene: “Psyche” in luogo di Psycho. Siamo dalle parti del Manganelli lettore di Pinocchio, che imbastisce una delle sue memorabili digressioni sul refuso “inverno/inferno”; o, più di recente, da quelle del Sofri alle prese con le traduzioni de La metamorfosi di Kafka. «Non v’è dubbio che l’uso di un refuso come indizio interpretativo sia, dal punto di visto della corretta filologia, assolutamente mostruoso», scriveva Manganelli; eppure, proprio seguendo questa “mostruosa” pista interpretativa, Vitiello ci conduce subito all’interno del thriller hitchcockiano, e per di più in una delle scene apparentemente più anodine. Lila (Vera Miles) e Sam (John Gavin) – rispettivamente sorella e amante di Marion Crane (Janet Leigh), brutalmente assassinata da un’ombra misteriosa sotto la doccia nella sua stanza al Bates Motel – si recano dallo sceriffo locale per denunciarne la scomparsa. Ebbene, alle spalle dei personaggi, appoggiata su una mensola rifilata sul fondo dell’inquadratura, c’è una statuetta in porcellana, una comune riproduzione in serie di un’opera di Canova. Si tratta di Amore e Psiche.
![Alfred Hitchcock, “Psycho”, 1960.]()
Alfred Hitchcock, “Psycho”, 1960.
![Antonio Canova, “Amore e Psiche”, 1787-1793.]()
Antonio Canova, “Amore e Psiche”, 1787-1793.
Anche se dichiara di non aver voluto “torturare” Psycho, di fatto Vitiello passa ciascuna inquadratura della pellicola «all’argano della moviola» per farle confessare ogni segreto. Inquisitore, dunque, ma anche restauratore (Psychoè qui considerato alla stregua di un dipinto o un affresco da passare ai raggi X) e persino curatore museale, poiché Una visita al Bates Motelè anche una sorta di minuzioso catalogo degli elementi che costituiscono il décor del film, squadernati uno per uno e disposti come pezzi di una collezione impossibile – o, per utilizzare una parola molto adoperata nel libro (e fin troppo di moda oggi, da Wes Anderson agli stessi volumi Adelphi), di una wunderkammer. D’altronde, secondo Vitiello, il Bates Motel è di fatto una wunderkammer da esplorare; e come tale lo tratta lo stesso Hitch, in veste di protagonista di un noto trailer del film, le cui orme il lettore del libro è invitato a seguire.
Che cosa scopriamo? Per esempio, che il quadro sotto cui si cela il pertugio attraverso il quale Norman (Anthony Perkins) spia Marion denudarsi, in una scena che è l’apice del voyeurismo hitchcockiano (e del voyeurismo novecentesco tout-court), è un dipinto di Willem van Mieris del 1731, trafugato nel 1972 e mai più ritrovato, che raffigura l’episodio biblico di Susanna e i vecchioni. Un dipinto del tutto coerente con la scena, dunque, ma non solo: qualche minuto (e poche righe) più avanti, Vitiello aggiunge un’ulteriore pennellata “warburghiana”, mostrando(ci) che il gesto disperato di Susanna in balia dei due assalitori, è riprodotto tale e quale da Marion ferita a morte: un omicidio che è quasi uno stupro, come già aveva osservato François Truffaut.
![Willem van Mieris, “Susanna e i vecchioni”, 1731.]()
Willem van Mieris, “Susanna e i vecchioni”, 1731.
![Janet Leigh in “Psycho”.]()
Janet Leigh in “Psycho”.
Ma Vitiello non si accontenta di fare da cicerone (o, per usare le sue parole, “mistagogo”) fra le varie stanze del Bates Motel e della magione annessa. Come indicano i titoli delle due parti in cui è grosso modo suddiviso il libro (“Misteri Minori. Bates Motel” e “Misteri Maggiori. Bates Mansion”), l’autore sembra individuare una sorta di messaggio cifrato tra le opere di questa ipotetica collezione. La statuetta pseudocanoviana di Amore e Psiche in casa dello sceriffo; le due Veneri presenti nel salotto del motel (a malapena visibile la riproduzione della Rokeby di Velázquez, un poco di più quella di Tiziano); le raffigurazioni allegoriche della primavera appese in casa Bates; la statuetta di Orfeo nella camera della madre di Norman, Norma… In un’intervista, citata da Vitiello nelle prime pagine del libro, sir Alfred spiega alla columnist Louella Parsons che il suo nuovo film (il futuro Psycho), sarà «un’escursione nel sesso metafisico». Informazione ironicamente criptica che Vitiello utilizza come indizio-chiave: da “normale” thriller, Psycho si trasforma in un percorso misterico in tre tappe, tre miti di amore, morte e rinascita.
Così, il film di Hitchcock è la storia di una Psiche (Marion) che insidia Eros (Norman) sotto lo sguardo minaccioso di una Afrodite invisibile e crudele (Norma Bates); ma è anche la storia di un Orfeo (di nuovo Norman) che non riesce a resuscitare la sua Euridice (la madre-amante Norma); e infine di una Proserpina (Mrs Bates, anche qui) che non tornerà più dall’Ade. «Un rito ciclico di morte e rinascita è celebrato nelle stanze di casa Bates», conclude l’autore. «La donna deve morire affinché, dalle sue braci, possa nascere la Diva […] è così per la signora Bates, avvelenata e sepolta per risorgere come grande fenice. Ma stavolta qualcosa è andato storto. […] Restava una Demetra ghignante dalle orbite nere». Psycho come morte dello star-system, quindi – e, più in generale, del cinema classico hollywoodiano: il film di Hitchcock esce nel 1960, lo stesso anno in cui La dolce vita di Fellini vince a Cannes la Palma d’Oro e nelle sale debuttano L’avventura di Antonioni e Fino all’ultimo respiro di Godard, capisaldi di quella che sarà la modernità cinematografica.
Si esce dalla visita colti da un leggero senso di vertigine. «Non si sa bene, al termine di questa appassionante lettura, se la perfezione del sistema […] sia frutto dell’opera che essi analizzano o soltanto del loro pensiero»: così, pochi mesi prima di morire, André Bazin recensiva la monografia su Hitchcock firmata nel 1958 da Claude Chabrol ed Eric Rohmer. La cautela del fondatore dei Cahiers du Cinéma vale anche per questa Visita al Bates Motel? L’impressione è che il libro ci dica più delle ossessioni personali dell’autore che non di quelle hitchockiane. Sia ben chiaro: era difficile dire qualcosa di nuovo a proposito di uno dei film più interpretati (o sovrainterpretati) della storia del cinema, che ha dato vita a tre seguiti ufficiali, una serie TV, un remake a colori “frame-by-frame” (lo Psycho di Gus Van Sant, 1998) e un numero incalcolabile di parodie e omaggi. E se forse il libro manca il bersaglio che si era prefissato, ne centra in pieno un altro: l’importanza, mai abbastanza sottolineata, del décor nell’opera del regista britannico: «Hitchcock non lasciava nulla al caso», scrive Vitiello. «Robert Clatworthy, uno degli scenografi, lo ricorda, prima del ciak, intento a disporre cianfrusaglie, ninnoli e soprammobili con un’attenzione maniacale».
![]()
All’ingresso della mostra Hitchcock et l’art, allestita a Montréal e a Parigi fra il 2000 e il 2001, nella quale venivano esposti, a mo’ di ready-made, gli oggetti che avevano fatto la storia (e le storie) del cinema hitchcockiano, erano riportati i versi di una poesia che Godard aveva composto per le sue Histoire(s) du cinéma (1988-98):
Abbiamo dimenticato/ su cosa/Montgomery Clift mantenga/ eterno silenzio/ e perché Janet Leigh/ si fermi al Motel Bates […] ma/ ci ricordiamo/ di una fila di bottiglie/ di un paio di occhiali/ di uno spartito/ di un mazzo di chiavi/ perché con questi/ e attraverso questi/ Alfred Hitchcock riuscì/ là dove fallirono/ Alessandro Giulio Cesare/ Napoleone/ avere il controllo dell’universo.
Il cinema come luogo del dominio assoluto. Non a caso, parlandone con Truffaut, Hitchcock definiva Psycho «l’esperienza più appassionante che ho fatto di gioco col pubblico. […] Non è un messaggio che lo ha incuriosito. Non è una grande interpretazione che lo ha sconvolto. Non è un romanzo molto apprezzato che l’ha avvinto. Quello che ha commosso il pubblico è stato il film puro».
Allontaniamoci dal Bates Motel e torniamo a Keaton, che abbiamo lasciato in balìa dello schermo cinematografico. Proprio il suo Sherlock Jr., infatti, ci può fornire un’ottima chiave d’accesso per il secondo libro di cui stiamo parlando. Mentre sappiamo quasi tutto del capolavoro di Keaton, pochissimo, anzi nulla, sapevamo invece di Hearts and Pearls, la pellicola che egli stesso proietta nel corso del film. Fino a oggi, quando, grazie al Dizionario del cinema immaginario di Anile, questo titolo negletto non è più soltanto un nome:
Hearts and Pearls or The Lounge Lizard’s Lost Love (Usa, 1924, b/n muto).**
Un giovane bellimbusto corteggia una bella ereditiera con lo scopo di sgraffignarle una preziosa collana di perle; a colpo riuscito, l’uomo si scopre innamorato della sua vittima, le restituisce il bottino e la chiede in sposa: convoleranno a nozze e avranno due gemelli. Melodramma leggero in cinque rulli, prodotto con gusto dalla Veronal Film Company. Non troppo originale ma di fattura gradevole e privo di svenevolezze. Ignoti regista e interpreti, non menzionati nei cartelli.
Di schede come questa ce ne sono altre 389, ciascuna completa di trama, giudizio e stellette (da * a ****). Tutte ispirate, con una ironia che non esclude l’affetto, a uno dei più noti dizionari dei film, quello di Paolo Mereghetti: il quale, dal canto suo, “benedice” l’iniziativa con una apposita prefazione. Cinema immaginario, ovvero i film che, come l’esempio appena citato, esistono soltanto all’interno di altri film. «Estrapolati dai film reali», scrive Anile nelle semiserie Istruzioni per l’uso, «i film immaginari ritrovano una trama coerente, rivendicano una critica onesta, rinascono a nuova vita, ottengono finalmente piena cittadinanza».
![]()
Conosciuto fra lettori e studiosi per i suoi saggi di storia del cinema (da Totò a Welles, da Rossellini a Visconti), Anile si è dato due contraintes nella sua compilazione: che il film “ospitante”, o porteur, fosse un’opera destinata alla sala cinematografica (pochissime le eccezioni: Vanità e affanni di Bergman, l’episodio di Masters of Horror diretto da Carpenter e The Other Side of the Wind di Welles); che il film “ospite”, o porté, avesse un titolo: niente scheda dunque per la trasposizione evangelica che si vede girare ne La ricotta di Pasolini, né per la pellicola che apre a mo’ di prologo Stardust Memories di Allen, né per il film pacifista che Emmanuelle Riva va a interpretare in Giappone all’interno di Hiroshima mon amour di Resnais.
Per il resto la schedatura copre oltre un secolo di cinema, dalle origini al 2019. Fra i titoli troviamo anche i film girati in Italia da Rick Dalton/Leonardo DiCaprio all’interno di C’era una volta a… Hollywood e Sabor, leggendario esordio di Salvador Mallo/Antonio Banderas rievocato nell’ultimo film di Almodóvar. Nessuna concessione all’autorialismo: il giudizio sul film-nel-film prescinde spesso dal valore sul film che lo contiene, senza distinzioni fra esempi celebri e semisconosciuti, capolavori e oscenità.
Il lettore si potrà imbattere in titoli emblematici: La rosa purpurea del Cairo (inteso come film-nel-film), che risulta purtroppo perduto poiché «tutte le copie della pellicola sono state ritirate e i negativi distrutti in seguito alla clamorosa sortita di un personaggio dallo schermo di un cinema del New Jersey»; Vi presento Pamela, al centro del truffautiano Effetto notte; l’Odissea diretta da Fritz Lang all’interno del Disprezzo di Godard («Sta al peplum come Metropolis sta al cinema di fantascienza»: quattro stelle).
C’è però spazio anche per alcune perle per i più cinefili, come le schede dedicate a See You Next Wednesday/Ci vediamo mercoledì, titolo che scorrazza a mo’ di tormentone in diversi film di John Landis; e persino a Le casalingue, il porno cui assistono inopinatamente Fantozzi e la signora Pina in una scena cult di Fantozzi va in pensione.
Al pari di Vitiello, Anile non esita a sottoporre un film allo scorrimento “frame-by-frame”, se l’indagine lo richiede. Si scoprono così dettagli inaspettati: qualcuno si era mai accorto, per esempio, che il titolo del leggendario musical morettiano sul pasticcere trotskysta, vagheggiato in Caro diario e parzialmente realizzato in Aprile, è La solitudine del trotskysta? E quanti sapevano che Coming Up Daisy, la commediola che Frances McDormand e George Clooney vanno a vedere al cinema in Burn After Reading dei fratelli Coen, è (nella finzione del film, ovviamente) diretta da Sam Raimi su sceneggiatura di Cormac McCarthy?
![Silvio Orlando ne “La solitudine del trotskysta” (da “Aprile” di Nanni Moretti, 1998).]()
Silvio Orlando ne “La solitudine del trotskysta” (da “Aprile” di Nanni Moretti, 1998).
Il Dizionario è un gioco. Anzi, come suggerisce l’autore stesso, «un gioco a quiz ad alta gradazione cinefila». Come tutti i giochi è programmaticamente “aperto”: ognuno cioè vi potrà trovare le proprie preferenze, lamentare le esclusioni e colmare eventuali lacune (personalmente, mi ha sorpreso l’assenza della Salomè diretta da Colin McKenzie, fantomatico protagonista del mockumentary di Peter Jackson Forgotten Silver, ma confido in una seconda edizione accresciuta). Un gioco, ma non uno scherzo. In apertura, Anile definisce il Dizionario «un atto di fede»; e, nella postfazione In lode del cinema immaginario, reindossa i panni dello studioso per approfondire e ripercorrere, non senza una punta di polemica, le fortune e i fraintendimenti cui è andato incontro il metacinema nel corso degli ultimi trent’anni.
Per almeno un decennio, tra la fine degli anni ’70 e la metà degli anni ’90, in piena sbornia postmoderna, il metacinema era avvertito come il primo sintomo della morte del cinema stesso: «Il succo del dibattito dell’epoca è che al cinema fosse rimasta soltanto la prospettiva di ripetersi con la consapevolezza del proprio mandato, ovvero di raccontare metaforicamente se stesso, alludendo di continuo ai meccanismi della visione».
Oggi sappiamo com’è andata a finire: il cinema sta per celebrare il proprio 125esimo compleanno, e, a dispetto delle innumerevoli trasformazioni e dei radicali cambiamenti nei modi di fruizione, appare ancora vivo e vegeto. «La tentazione, il desiderio, la voglia di parlare di cinema nel cinema, o di cinema col cinema, non è appannaggio esclusivo di un’epoca post-qualcosa, ma attraversa tempi, culture, continenti diversi». Il metacinema può essere molte cose: omaggio, critica, riflessione. Eppure, suggerisce l’autore, esiste una distinzione fondamentale: un conto è ricostruire in un film la lavorazione di una pellicola del passato (da Ed Wood di Burton a Celluloide di Lizzani), altro è creare un’opera ex nihilo per poi raccontarne la storia all’interno di un altro film. «Quando Ettore Scola rimette in scena in C’eravamo tanto amati il set della Dolce vita, con i veri Fellini e Mastroianni», scrive Anile, con un paragone particolarmente azzeccato, «il suo sforzo è quello di evocare qualcosa di esistente cercando la maggiore somiglianza possibile. Quando invece lo stesso Scola nella Terrazza propone L’apostata, “scandaloso” film immaginario da proiettare in una snobistica anteprima […], ha dovuto pure scegliersi nuovi volti, un nuovo stile, immaginare una trama minimamente originale». In altre parole, ha dovuto compiere un’operazione creativa.
![La troupe di “I sopravvissuti” (da “Lo stato delle cose” di Wim Wenders, 1982).]()
La troupe di “I sopravvissuti” (da “Lo stato delle cose” di Wim Wenders, 1982).
In casi come questo, la mise en abîme non è soltanto un’operazione gelidamente teorica. «Se per il regista il film è una specie di figlio», scrive ancora Anile, «il film immaginario dentro il film reale è una specie di nipotino, gracile e incompiuto». Un “oggetto” che va maneggiato con delicatezza e dal quale, talvolta, ci si congeda persino malvolentieri. «Sono contento di come è riuscito questo film», ha dichiarato Wim Wenders a proposito de Lo stato delle cose, «anche se, forse, non avrei dovuto interrompere il “film-nel-film”».
Lo stato delle cose si apre appunto con un prologo che fa il verso all’ultimo film diretto da Allan Dwan, The Most Dangerous Man Alive. La pellicola, un esempio di science-fiction distopica, si intitola The Survivors, “I sopravvissuti”. Trascorsa una settimana di riprese, racconta Wenders, uno strano incantesimo sembrava essersi impossessato della troupe: «gli attori cominciavano a sentirsi a loro agio nei ruoli, nei costumi e avrebbero voluto continuare quel film». Il regista ricordava di aver girato la panoramica con cui si passava da The Survivors al suo dietro le quinte «nel dispiacere generale». Come molti film sul cinema, Lo stato delle cose racconta dell’impossibilità di portare a termine una pellicola “maledetta”, una resa all’impossibilità di raccontare storie sul grande schermo. «Le storie esistono solo nelle storie», spiega alla sua troupe Friedrich Munro (Patrick Bauchau), regista del film-nel-film, rimasto senza fondi per proseguire. «Un’idea preconcetta», ribatte lo stesso Wenders. Però, una volta sul set, il film porté, il B-movie di fantascienza, gli era sfuggito di mano e lottava per non morire, sacrificato sull’altare di un mero assunto teorico. Non ce la farà, ma riuscirà a inoculare un po’ della sua fiction nel corpo del film principale: «Un po’ di finzione salva quest’opera di “anti-finzione”», conclude Wenders: «Allan Dwan ha finito per vincere».
A dispetto delle apparenze, il Dizionario del cinema immaginario, questo singolare capriccio vagamente oulipien, si rivela allora qualcosa di più serio. Un tuffo talmente profondo nel grande schermo da spingersi ben oltre la pura e semplice ossessione. Più che un atto di fede, è una dichiarazione d’amore: non nei confronti del gesto creatore del regista-demiurgo, ma di chi il cinema lo pensa, lo vive, lo fa.