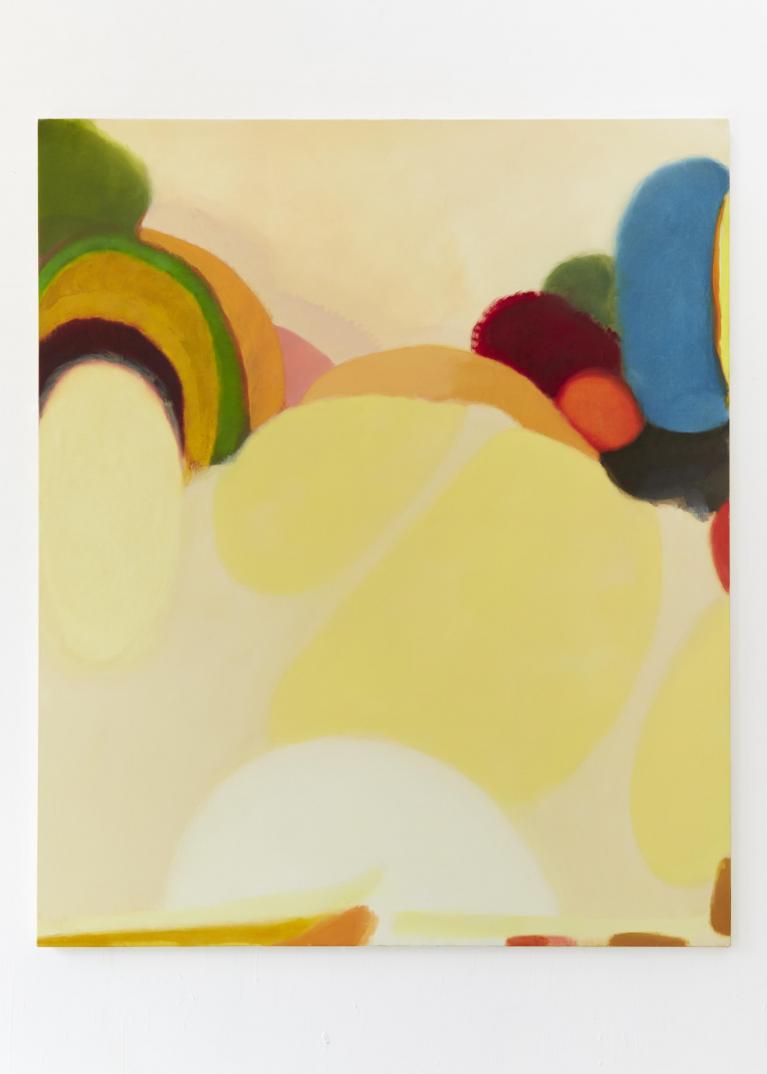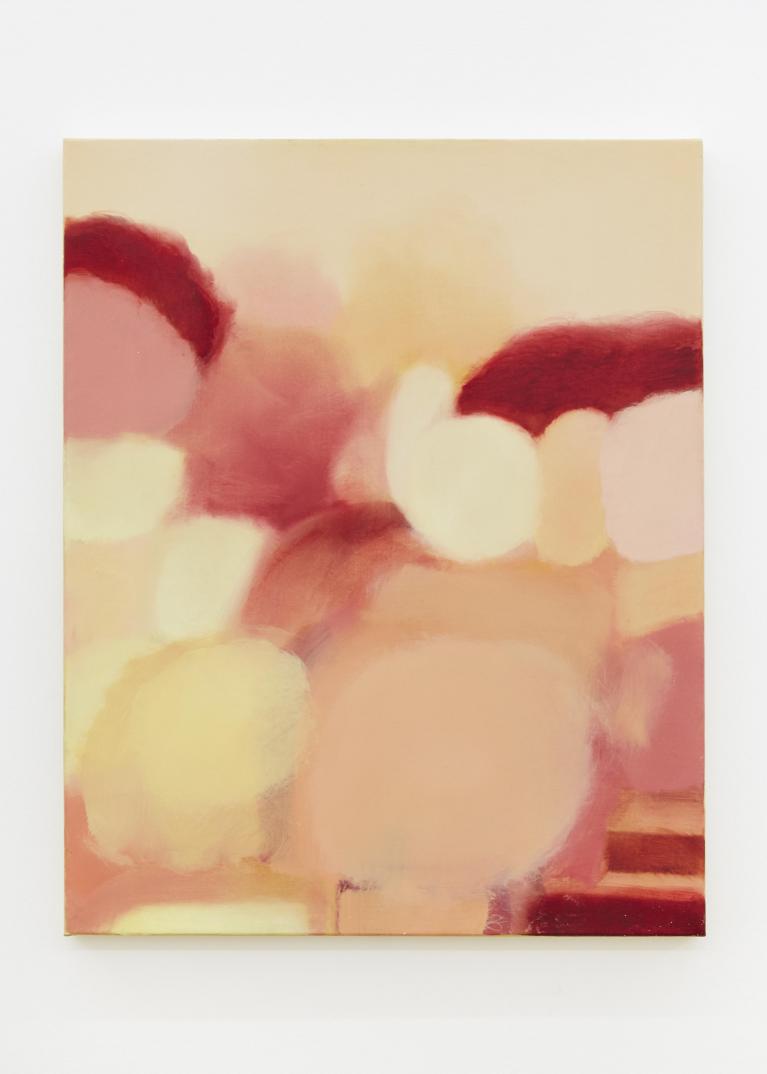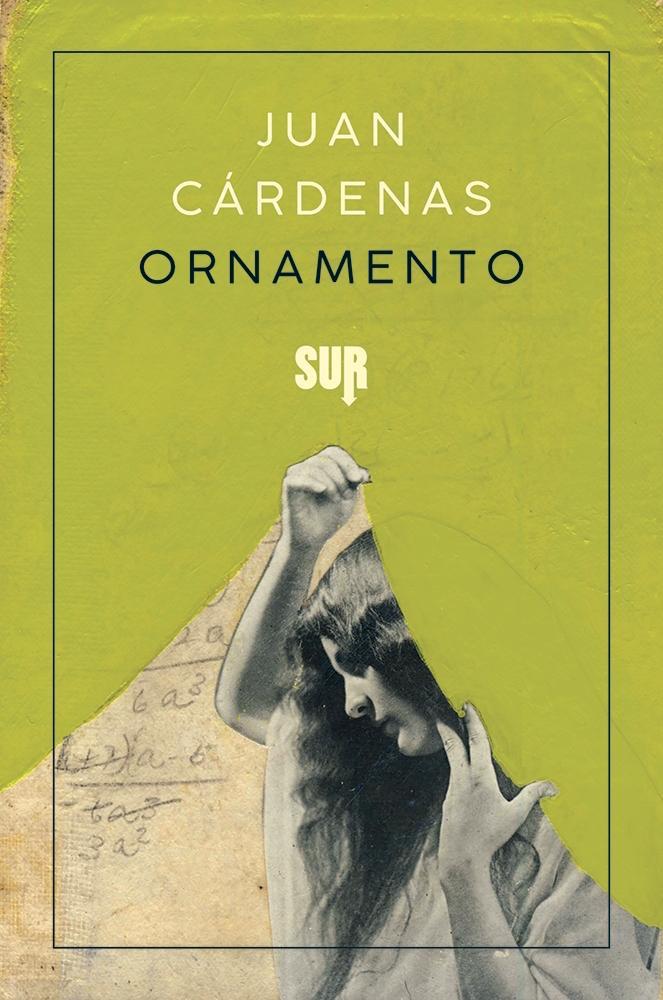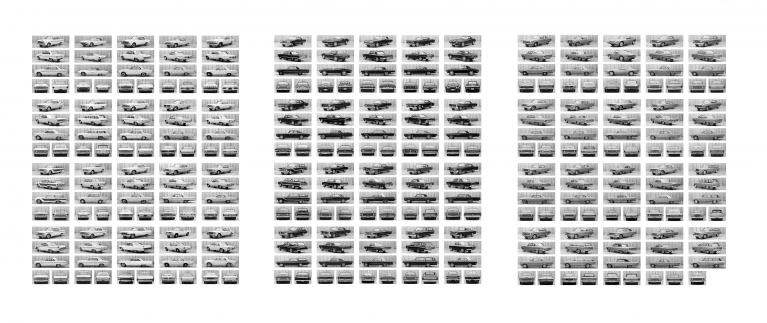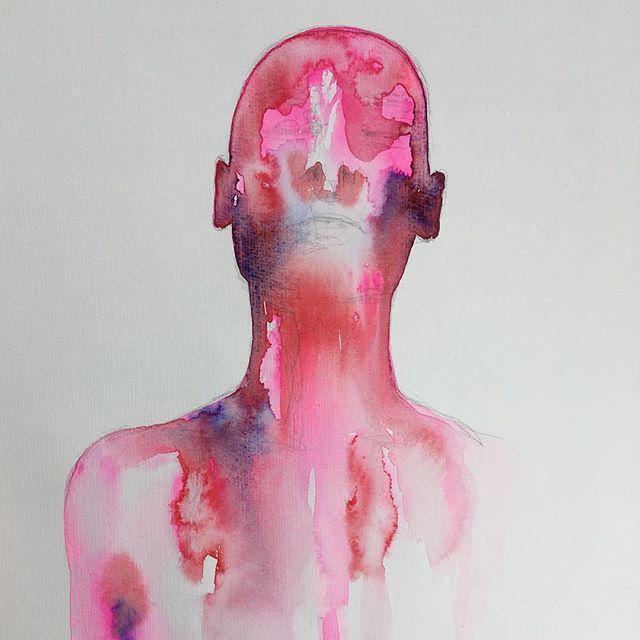Il maschio nero come fantasma sessuale. L’uomo nero come incubo dell’uomo bianco, come corpo forte, muscoloso, “selvaggio”, rapinatore di donne bianche, come pericolo da dominare, da ridurre in schiavitù, da tenere a distanza, da linciare quando esce dai binari consentiti. Di questo parla Bugie bianche. Capitolo primo: Black Dick di Alessandro Berti, rappresentato in prima assoluta al teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno (BO) per Gender Bender, il bel festival diretto da Daniele Del Pozzo dedicato a film, idee, performance, mostre, spettacoli di teatro e danza sulle mutazioni che attraversiamo, una proposta del Cassero Lgbt Center sugli “immaginari prodotti dalla cultura contemporanea legati alle nuove rappresentazioni del corpo, delle identità di genere e di orientamento sessuale”.
Bugie bianche / Black Dickè uno spettacolo sul razzismo, sul machismo e sulla violenza in forma di raffinata conferenza, di pacata conversazione, che si tinge di ironia spinta fino al sarcasmo, si accende e porta per strade molto diverse da quelle che sembrava aver imboccato inizialmente. L’attore e autore viaggia negli stereotipi sul sesso del nero (si chiama Black Dick, non solo per pudore di non sparare la traduzione, cazzo nero, ma anche perché alterna italiano e inglese, smontando modi di dire, frasi fatte o gergali, rivelandone le parti nascoste). Berti ci prende per mano con un tono inizialmente didattico, che presto ci tradisce, ci trasporta nella violenza degli impulsi e del mercato, nella contraddizione di neri emarginati che per reagire all’oppressione dei bianchi si trasformano in clown, in menestrelli, in neri come li vogliono i bianchi, o in ribelli che indossano però tutti gli stereotipi forgiati dalla parte contrapposta. L’attore collega momenti storici e del presente apparentemente lontani, dai campi degli schiavi alla ribellione degli attori porno neri che rifiutano di indossare nei loro film la maschera del violento rapinatore, brutalizzatore di donne bianche con le treccine, attuando un vero e proprio sciopero, che impone alle case produttrici, rette per lo più da bianchi, di rinunciare a storie basate su figure troppo schiave di pregiudizi razziali, pena il rifiuto degli attori a interpretare quei copioni.
Salta dal linciaggio dell’uomo nero che ha rapporti sessuali con la donna bianca al turismo sessuale fino alla forma dominate di sesso odierna, quella della pornografia:
Dovrei parlare del turismo sessuale, delle donne europee, americane, di mezza età, in Giamaica, Cuba, a Zanzibar, o del presunto viavai di signore, a Pietrasanta, davanti al centro d'accoglienza, che barattano un rapporto sessuale, in cambio di una ricarica da dieci? No, preferisco: guardare cosa fa la maggioranza. La maggioranza adesso, lo sapete, siete voi, siamo noi, sta davanti a uno schermo, guarda, clicca. Quindi vorrei parlare adesso qui, di un campo molto importante, del discorso sessuale, cioè la pornografia. La svolta smart ha reso il porno fruibile, da tutti, da tutte, a portata di dito, col dito col dito l'orgasmo è garantito, ha interpretato, a suo modo, quello slogan, di cinquant'anni fa.
[…]
In America, tra utenti donne di pornografia, la ricerca di categorie tipo black dick, black thug, black thugsfuckin rough, cioè cazzo nero, teppista nero, teppisti neri che scopano duro, da dieci anni è in crescita costante, esorbitante: del 300%, quindi la donna bianca americana does not date interracial, cioè non ci non va, poi davvero, con il nero, non tanto, secondo le statistiche, ma ha fantasie interrazziali, cerca in rete black dicks,black thugs, definizioni volgari che queste stesse donne, nella vita, non userebbero mai, così come i nomi dei siti, specializzati nel porno interracial, probabilmente non piacciono alle donne: blacksonblondes, cioè neri sopra bionde, blackscrewblondes, cioè neri intenti a chiavarle, le bionde, whatdowhitewomenwant, quel che le bianche vogliono, teensloveitblack, le ragazzine lo adorano nero, ma anche le più mature, a giudicare dal sito momgoingblack, cioè la mamma adesso è andata con il nero, e via così.
![]()
Il testo porta continuamente da un’altra parte, in un viaggio nella storia di uno sguardo, quello del bianco sul corpo nero. Dal porno “interracial” tra attori neri e attrici bianche, si arriva a Mohamed Alì, a Malcom X, al collaboratore gay di Martin Luther King e al suo outing davanti ai nonni, alle Pantere Nere e alla loro natura anfibia, di organizzatori di resistenza culturale e di assistenza nel ghetto, colpevoli spesso di violenza e machismo. E racconta di come quella cultura sia passata nel rap, nelle bande nere:
Le Pantere hanno perso, sul campo, l'FBI le ha divise, sconfitte.
E nel tempo il militante politico, degli anni ‘60, armato ma per selfdefence
Con sempre il codice penale con sé, delegato da una comunità,
Si trasforma, tiene solo l'involucro, il look e diventa, venti, trent'anni dopo,
La figura del Gangsta, da solo, violento, drogato
Del Rapper che scopa, che spara, che sniffa
Prima il membro politico, ora il membro virile
L'organo del partito, adesso organo e basta, esibito
La pistola è il mio cazzo, my rod, lo diceva già Cleaver, la verga, la lotta
Per l'uguaglianza diventa: la battaglia di ognuno per farcela, solo, isolato, laffuori, una guerra,
tra tutti, con tutti, cioè esattamente quell'agonismo bianco, self made man versus self made
man, che era stato, per secoli, estraneo, al retaggio, alla cultura dei neri.
E poco prima aveva notato:
Però sta storia dell'esser stati castrati, e devirilizzati, come schiavi, che è vero, non c'è dubbio, però: l'avete usata, maschi neri, dice Bell Hooks, come una specie di mantra, una scusa, per non muovervi da lì, e giustificare, la violenza, vostra adesso. Avete preso a modello proprio loro, i maschi bianchi, i padroni, che violentavano le vostre donne e linciavano voi! Alla fine, è il loro stesso modello che adesso, riproponete.
[…]
Cioè quindi secondo te piano piano, generazione dopo generazione, il maschio nero, sarebbe diventato, esattamente come il maschio bianco? Io dico solo che era il modello che aveva, di uomo libero, il capo, il maschio onnipotente, il maschio nero spiava: come il padrone trattava la moglie, le figlie, hot stuff here boys...
In questi brani il tono fa vedere lo spettacolo. Berti si rivolge agli interlocutori, in numero limitato per sentirli più vicini: parla con loro come se facesse un discorso, avanza dati, osservazioni, con ironia, e obietta alle proposizioni appena avanzate, dentro sé stesso. Il tono “naturale”, normale, da conversazione, si sgretola sotto le domande, sotto le destrutturazioni e gli slittamenti del linguaggio corrente, aprendo strade all’immedesimazione in pezzi più teatrali verso la fine. Con un gran paradosso, come vedremo.
![]()
L’attore rievoca intanto vari personaggi della cultura black, fino a Eldridge Cleaver, ministro dell'informazione e portavoce delle Panthers, che nel 1968 scrive il libro di saggi e autobiografia Soul On Ice, anima in ghiaccio, lui che avrà un percorso di vita che va dal partito nero a Ronald Reagan e a varie forme di misticismo settario, esempio di nero che cerca le strade più eteroclite per sfuggire a una condizione di soggezione. E arriva fino all’abbraccio tra Trump e Kayne West, “tra il razzista del Klan ed il Rapper”. È un mulinello di notizie e di idee.
Finalmente Berti si concentra sul racconto di una canzone, la canticchia, assumendo una maschera deliberatamente teatrale. Papa Was A Rolling Stone dei Temptations è un dialogo tra un figlio che chiede chi sia il padre, che non ha conosciuto, e la madre che risponde: “Son… Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, all he left us was alone”: “Figlio, tuo padre era un vagabondo. Dove poggiava il cappello, là era la sua casa. E quando è morto ci ha lasciati soli”. E fa notare che alone suona come a loan, un’ipoteca, un debito.
Riprende il tono da conferenza confidenziale, Berti, e commenta:
È una canzone strana, bellissima, che dura sette minuti, una durata pazzesca per una hit, con un prologo musicale esorbitante, di quattro minuti, cioè più lungo della parte cantata, che il gruppo, The Temptations, si divide, in modo piuttosto strano, tra falsetti, pezzi più bassi, controtempi.
I cinque cantanti neri sono vestiti di rosa, ballano, scherzano, e sembrano interpretare con distacco, con ironia, una canzone il cui testo ripropone l'immagine di maschio nero traditore, debitore, giocatore, incantatore, inaffidabile, infantile, sempre in giro.
The Temptations sembrano essere autoironici, staccati, superiori.
E subito svela come la band non fosse a proprio agio in questa hit, forse proprio per il testo. Cerca, Berti, in questo montaggio e smontaggio, la tinta originaria che sta dietro le incrostazioni, la realtà sotto le apparenze, le mistificazioni, il corpo nero mercificato, ridotto, ancora abusato, come nei linciaggi.
Quando ho cominciato a scrivere questa parte, dello spettacolo, in cui Bell Hooks e Cornel West dicono ai neri: sveglia, non cadete nelle trappole dei bianchi, non accettatelo il ruolo che vi offrono, di menestrello sessuale, ero a disagio perché questo progetto, nasce da una mia esigenza di difendere, proprio da questo, i maschi neri, qui oggi, da noi, da questo stereotipo. E parlare anche del fatto che succede, può succedere, che un nero invece, coscientemente o meno, sia a suo agio, in questo stereotipo, diventi: il cazzone, il machista, il sessista, che l'uomo bianco è sempre stato, e gareggi con lui a chi l'ha più lungo,
Bene, questa parte di lavoro mi imbarazzava, anche se la ritenevo necessaria, importante, e mi sono ricordato di episodi recenti, in cui artisti bianchi sono stati accusati di appropriazione culturale, cioè di usare una storia, un problema, legato a un gruppo minoritario, in un modo politicamente scorretto.
E qui un’altra capriola verso di sé, verso la nostra cultura e il nostro rapporto con un mondo più vasto delle nostre piccole patrie, ora in una terra di mezzo tra la conferenza e la recita, con un’aria di confessione personale. Il politicamente corretto concede l’autorizzazione a parlare delle minoranze solo a esponenti delle minoranze medesime, e ad assurdi come quelli capitati al regista Roberto Minervini, che non ottiene un finanziamento per girare, lui bianco, un film sui neri in Louisiana:
Al che lui risponde, giustamente: ipocriti, siete tutti dei bianchi, chi decide, a chi dare sti soldi e a chi no, è bianco, e cerca un nero per fargli l'elemosina? Daiiii, lo sai benissimo che in questo paese, il cambiamento può essere solo top-down, dall'alto al basso, e io che uso quel po' di potere, che ho come bianco, per parlare di qualcosa che mi preme: l'ineguaglianza, tra bianchi e neri, in America, non ne posso parlare in quanto bianco, vaffanculo.
Ha ragione. Sono d'accordo con lui.
È tutta una questione di potere? Potere contro potere, fino alle cornate, alla lotta, alla battaglia. Impossible ricomporre le divisioni, colmare le distanze?
![]()
E qui arriva il finale, tutto basato sul racconto di Strange Fruit, la meravigliosa triste canzone sui linciaggi, sui neri assassinati penzolanti a un albero, scritta da Abel Meeropol, un bianco ebreo e comunista e cantata da Billie Holiday (si sente in sottofondo, la canzone, mentre avanzano immagini su un piccolo schermo e l’attore torna a recitare e a canticchiare). Emozione. Orrore. Compassione. Forse voglia di ribellarsi. Magia di un teatro che diventa confessione di qualcosa di sepolto dentro ognuno di noi.
In questo pezzo e in quello sulla canzone dei Temptations, credo, stia il segreto che fa di questa conferenza sul fantasma sessuale del nero un vero grande spettacolo capolavoro. Berti in realtà recita mentre snocciola dati, all’inizio, facendo finta di condurti con discrezione in una realtà da conoscere meglio. Assume il ruolo insinuante del velaraccontoiolaverità e continuamente smonta il discorso costituito con colpi di scena linguistici e testuali, con ammiccamenti, con una ritualità sulla ricerca della verità, irta di salti, di deviazioni, di difficoltà, di rovesciamenti esercitati con virtuosismo attoriale consapevolmente dimesso. E poi recita questi due pezzi che ti stringono la pancia, il cuore, l’intelligenza, diventando, con la distanza della maschera, verissimo, portandoci nel cerchio magico emozionante della tragedia, noi, complici o semplici spettatori o sodali. Insinua l’idea che l’unica strada, contro il razzismo, contro il pregiudizio, contro una realtà ridotta a paure, spettri, incubi, e rivendicazioni, aggressioni, atteggiamenti di superiorità, l’unica via sia quella di costruire ponti verso gli altri, ascoltando. E allora anche questo spettacolo che parla di attori porno, di donne in calore, di bianchi che linciano o si fanno succubi e di neri che accettano le maschere deformate che vengono imposte loro e le rinforzano, in una lotta alla resistenza che si trasforma in aggressione, anche questo spettacolo diventa una tappa del teatro mistico di questo attore reggiano installatosi a Bologna, che preferibilmente mostra i suoi intimi intensi monologhi o scarni dialoghi in casa sua, lo spazio Casavuota in via San Felice.
“Mistico” ho scritto, perché Berti indaga i misteri della vita. Lo ha fatto in Un cristiano, la storia del martirio di don Fornasini nella strage nazifascista di Monte Sole a Marzabotto, l’eroismo e l’altruismo di un uomo comune guidato da un’idea di relazione alta con gli altri che chiamava fede. L’ha fatto in quel bellissimo lavoro che è Leila della tempesta, l’intenso dialogo-scontro-ricerca tra una detenuta di fede islamica, arrestata per spaccio, e un monaco. La strada che unisce i due precedenti lavori, apparentemente a dominante tematica religiosa e sociale, con questo, dichiaratamente un’indagine che ruota intorno al sesso e alle sue rappresentazioni, è la necessità di incontro umano, che trasformi posizioni, figure sociali dominanti, vetuste, mortifere. Una ricerca di relazione, di anima, perpetrata senza esclusione di colpi.
La storia dei neri in America ci dice che questa paura deforma sia il bianco che il nero, ci cambia, ci rende qualcosa di meno, di peggio, di quello che siamo. Siamo runaway slaves, ormai tutti, e scappiamo, scapperemo, mischiati, braccati, e tra poco, servirà qualche cosa di più, di diverso.
Queste parole sentiamo dire verso la conclusione, quando la sua voce, fintorecitante, ci è suonata cristallina di note vere, che si scolpiscono dentro, a fondo. Come quando, subito dopo, dà la parola, ancora con lo stile finto documentario, a James Baldwin, in un testo ripreso da un’intervista della televisione olandese:
“Se non usate noi come un esempio, voglio dire: l'esempio americano…
Voi dovreste imparare da tutti gli orrori perpetrati dai vostri figli...
È questo che non siete capaci di accettare.
Voi lo chiamate un problema con la minoranza.
Ed è vero che i neri, o i non bianchi, sono una minoranza in qualsiasi capitale europea.
Ma noi non siamo una minoranza nel mondo.
Voi siete la minoranza.
È questo che non riuscite a guardare in faccia.
Sì, alla fine voi avete i razzi spaziali, le banche e le armi.
Ma quello che non avete più è: me.
Me, me, me.
Io, lo schiavo.
Io, il negro.
Io, il gatto nero.
Che credeva a tutto quello che dicevate, una volta.
Niente che tu possa fare mi convincerà mai che io ho meno valore di te, bambino mio.
Né in cielo né in terra. È finita.
Io ti ho sopportato per tanto di quel tempo, ora tu devi sopportare me.
E sono venuto per restare. Capisci?”
“Dobbiamo vivere la stessa vostra storia?”
“Spero di no.
Se fossi in voi, se fossi in voi studierei, la prenderei come una dimostrazione pratica…
E non fate quello che abbiamo fatto noi.
Non dovete costruire un'altra Harlem
Solo perché l'avete già fatto una volta.
Assolutamente no.
Non dovete fare quello che hanno fatto i vostri figli.
Dovete imparare da questo esempio, e capire che non è una questione romantica.
È una verità che non si può dire.
Tutti gli uomini sono fratelli, questo è il nocciolo della questione.
Se non la afferri così, non la afferri proprio.”
E il ritmo ci trascina, placido, cullante, come una verità sussurrata sottovoce, con arte che si esibisce per nascondersi e per lasciarci soli davanti alla nostra responsabilità. Una voce di quelle alle quali non si può impedire di sconvolgerci. Semplicemente.
Le fotografie sono di Daniela Neri